Matteo Martini
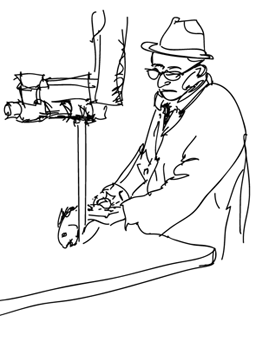
Il falegname dei pesci
Si trovava in una piccola via del centro, tra chi rammendava tappeti e chi accontentava con poco la solitudine di vite che si sciolgono lentamente come cera scaldata da una debole fiamma. Era un budello di cinque o sei metri, senza insegna o un cartello anche scritto a mano che indicasse il genere di esercizio, l’eventuale merce in vendita, i prezzi. Niente di tutto questo, sembrava quasi che fosse aperto per sbaglio o che forse, quel posto, era solo un deposito che non contemplava affatto il commercio al dettaglio. Invece no, era proprio un negozio aperto al pubblico. Non era invitante entrarci, oltre al gelo che emanavano i congelatori, si provava disagio per l’assenza di colori, ad esclusione di quei verdolini spenti delle muffe fiorite sui muri. Il banco d’acciaio sembrava una superficie repellente a qualsiasi tragedia, una volta ripulito appariva con la sua luce implacabile di sempre e così anche le piastrelle sbreccate, che ricoprivano per la parte inferiore i muri del locale. Al di là del banco, un uomo baffuto e imbacuccato attendeva immobile come i suoi pesci congelati appena morti da chissà quanto tempo. Sopra il cappotto, un grembiule di spessa gomma nera lo proteggeva dai trucioli di polpa grassa che schizzavano ogni volta che segava un pesce. La coppola era così ben calzata sul capo, che immaginavo il calco sui suoi capelli prima di andare a letto come un segno indelebile del suo immutabile aspetto. “Mi sega un pezzo di quello?”, la sega circolare modulava lo strazio anatomico di quei corpi ibernati, si riconosceva il suono della lama che affondava nella polpa e all’improvviso trovava un ostacolo e il suono si assottigliava diventava più acuto, come un urlo in un sogno soffocato tra l’inconscio e il mondo reale. Il risultato finale erano dei cubi perfetti, la forma originaria si era trasformata, e quella solida forma geometrica negava una storia di migrazioni sinuose, di virtuosi scivolamenti, di pura libertà. I pesci più piccoli venivano graziati, semplicemente perché non c’era bisogno di tagliarli, l’uomo li prendeva in mano e con le pinze gli spezzava le spine dorsali, timoni in avaria diventati scomode escrescenze, impurità inutili e pericolose. Si tornava a casa con quella strana tristezza di chi assapora una zuppa di pesce a tremila metri di altezza.
Questo non è un sasso
Ci sono luoghi dove non è necessario tornare di tanto in tanto per vedere se sono ancora li, se sono cambiati, e se si, di meravigliarsi pensando come erano rimasti nella memoria. Basta vederli una volta per entrarci dentro. Non sono luoghi degni di nota, la loro bellezza è nascosta dall'uniformità apparente di un immagine precostituita che ha poco a che fare con la loro reale conformazione, con la loro essenza. Non hanno una ubicazione precisa perché si possono trovare ovunque, ma spesso si cercano dove si pensa che nessuno sia passato di li . Si possono trovare solo se ci si spoglia della certezza che tutte le cose esistono perché le vediamo. Se sto camminando e guardando per terra dico: "questo è un sasso", quello che ho visto non esiste più, diventa come miliardi di altri sassi, ma i sassi non sono uguali. Ecco che davanti all'infinito, che non è nella distanza delle galassie, ma su questo mondo, proprio sotto i nostri occhi, si semplifica, riducendo il campo alle nostre dimensioni. Si vive bene ma lontani dalla realtà. "Bisogna chiamare le cose con il loro nome", sembrano parole sacrosante, ma in realtà le cose non hanno un nome, siamo noi che glielo diamo. Quando si da un nome a una cosa ne entriamo in possesso, diventa come molte altre e perde d'interesse. Per entrare nell'anima delle cose bisogna interpretarle, la metafora può essere uno strumento comparativo che distacca e avvicina allo stesso tempo. L'anima entra nell'anima senza dare nomi, senza definire, allora, solo allora la mente si accorda sulla stessa tonalità armonica di quello che hai davanti, qualcosa che non è la stessa rispetto nient'altro.

Gli indovini del tempo
Odio le previsioni del tempo, come odio coloro che passeggiano con l’ombrello quando non piove ancora, questo modo di non essere mai sopraffatti da sorprese, neppure da quelle che ci offre il cielo. Programmiamo lavoretti, chiacchere e mangiate pantagrueliche sull’orlo della strada, per queste avvilenti occupazioni dobbiamo sapere che tempo farà. Ci sono degli addetti a questo ingrato compito che per dimostrare la loro credibilità spesso si addobbano di medaglie e bottoni d’oro. Sono gioviali, ma distaccati, non parlano mai in prima persona, sarebbe un rischio troppo grosso per loro; fanno in modo che le carte parlino per loro, quelle geografiche s’intende. Spesso hanno una bacchetta in mano che serve per indicare, ma che ad ognuno di noi ci riporta indietro nel tempo, quando si veniva scoperti per una marachella o per non aver fatto i compiti. La bacchetta è un modo per dire: “stai attento se non vuoi prendere l’acqua domani”. Agitandola, simulano bufere, spingono cumuli per centinaia di chilometri e ho sempre pensato che loro sono sempre sopra a tutto, che la loro divisa impeccabile da anni è così perché non un solo fiocco di neve o una goccia d’acqua è caduta sopra. Per questo, chi fa le previsioni del tempo mi è sempre sembrato molto lontano, anche per il linguaggio che usa così diverso da quello comune. Quanti di noi si sono messi a piangere sentendo dire “vortice depressionario”, sembra una condizione dalla quale è molto difficile uscire! Quanto ci siamo arrabbiati sentendo dire “fulmini globulari”. Anche le zone geografiche vengono chiamate in maniera diversa: “penisola Iberica” per esempio, invece di dire Spagna e Portogallo, che bisogno c’è? Comunque quel sorriso e l’augurio di una buona giornata a conclusione delle loro previsioni mi è sempre sembrato lo sberleffo di chi fa il brutto e il cattivo tempo.
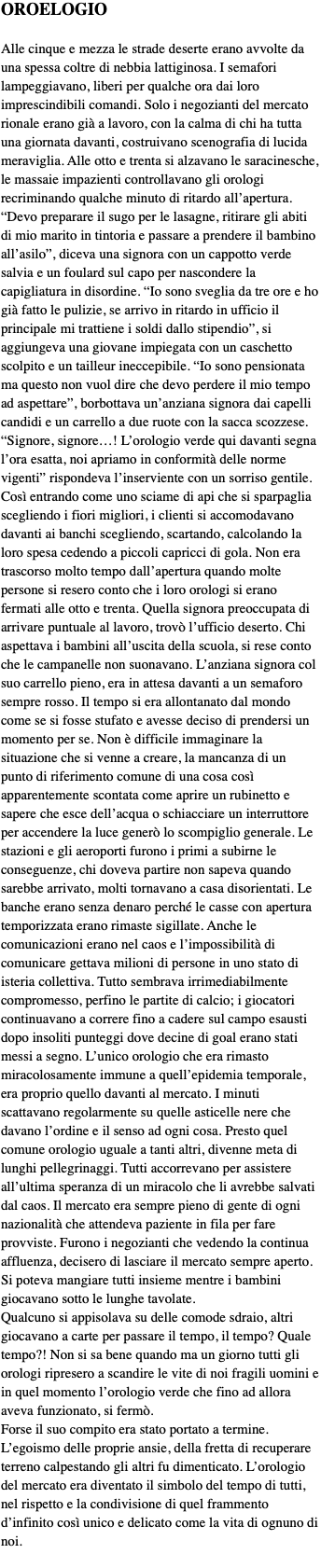
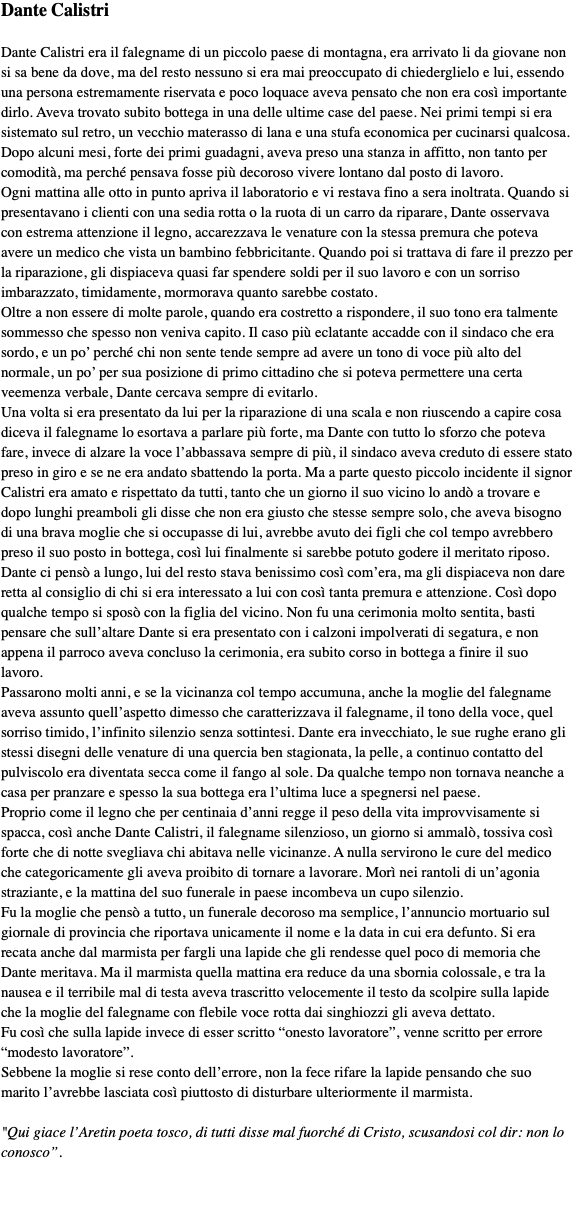
Verso sera
quando l’arsura ha mutato
la terra con pietra,
l’acqua scorre nei solchi,
scioglie le forme dell’aridità
dando sollievo a quelle foglie tristi.
Ma quando tutto è sommerso
un piccolo smeraldo zoppicante
arranca cercando salvezza.
Diserbo
Il verde velluto
tinto di giallo sul capo
abbraccia la terra con dolcezza.
Le corone radenti,
piccole inezie dei nei di campo,
si aggrappano ai sassi
come trapezisti
a gestione familiare
Le stelle rosse,
sprofondate come meteore,
restano anche dopo
averle rimosse.
Il buon cammino
Mi sono chiesto perché
non esista importanza
nel chiedersi dove viviamo.
A volte basta guardare
una fila di palme sofferenti
suddite di una statua
che ha perso l’anima.
Case vestite di rassicurante benessere
sfoggiano i segni della solitudine.
Meglio aspettare un treno
in una stazione abbandonata
senza sapere che ora è.

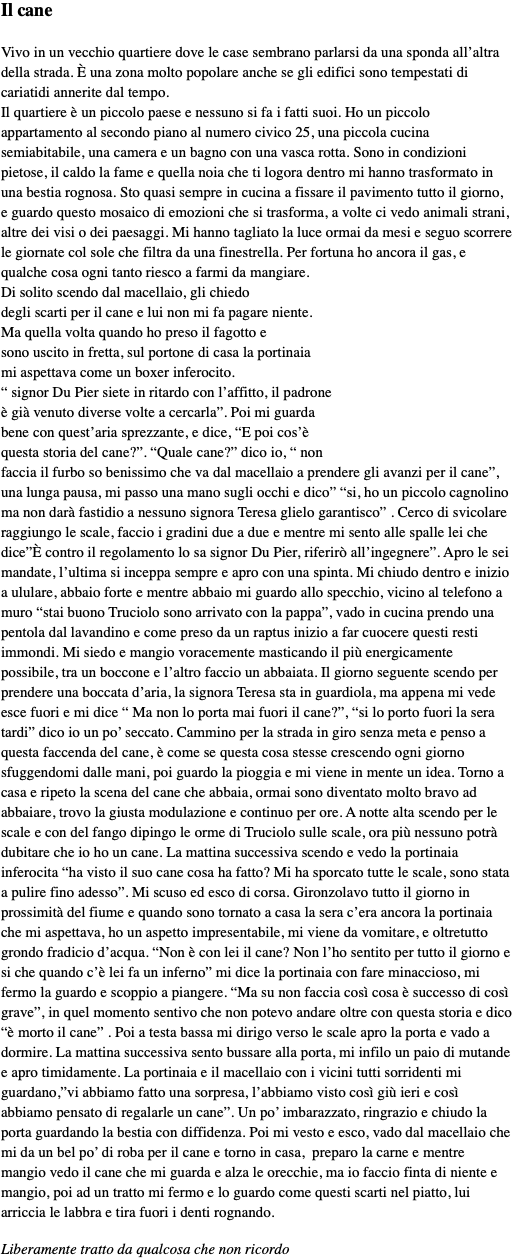
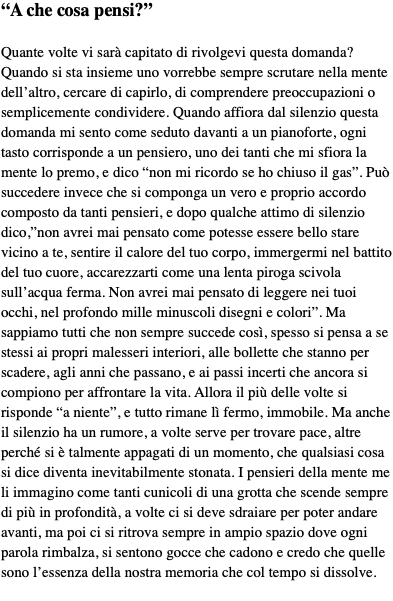
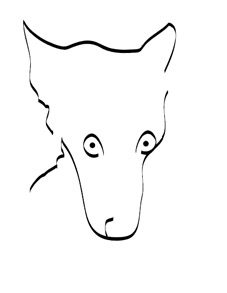
Nascita
Era una bella giornata 56 anni fa, alle 9 e trenta circa scoppiò un temporale, uno di quelli con tanti tuoni e lampi, fragoroso come solo possono essere le tempeste d’estate. Qualcuno, perfino, aveva acceso la luce da quanto si era oscurato il cielo, sulle finestre della sala d’aspetto battevano gocce di pioggia che si riunivano in rivoli prima di cadere a terra. Per il resto tutto sembrava normale, sembrava un giorno qualsiasi come tanti altri ma non era così per me. Il colore degli ospedali non è un colore, freddo e acutamente chiaro si riconosce subito perché nessuno lo usa. Che cosa starna vedere i letti con le ruote, li si immagina sfrecciare su una strada a largo scorrimento come in un fumetto di Little Nemo, attaccati alla spalliera con il vento nei capelli mentre le lenzuola lasciano la scia svolazzando. In pigiama si può andare dappertutto, ti aprono le porte ai grandi magazzini e si scompare in una nuvola di talco. I neonati piangono perché non hanno nient’altro da fare, i primi movimenti delle braccia e delle mani sono a rallentatore come quelli di animali preistorici che sono vivi ancora adesso, bestie misteriose che risparmiano su tutto. Si sente profumo di fiori che si mescola a quello del disinfettante, c’è qualcuno che fuma in un piccolo angolo adibito alla vergogna, il grande posacenere trabocca di cicche, da ognuna si capisce qualcosa, quella che è stata spenta nervosamente prima della sua fine, un’altra lasciata li, divorata dalla combustione, alcune sono col filtro sporco di rossetto altre sono li da chissà quanto. Ad un tratto irrompe il suono di un altoparlante la voce gracchia e non si capisce bene, poi quei pochi che aspettano si guardano tra loro, ma lei ha capito qualcosa? No ma mi sembra che abbia chiamato qualcuno. Tutti iniziano a rilevare la loro identità sperando che qualcuno avesse colto un brandello del loro nome e subito nasce l’occasione per stemperare il nervosismo scambiando due parole, sa siamo qui dalle 4 di stamattina, ma ancora niente… ci facessero almeno sapere qualcosa. Un grande orologio fa scattare i secondi come i colpi di un lanciatore di coltelli, chissà chi lo decide quando si deve nascere, la madre che spinge con tutta la forza che ha o il figlio che si è stufato di stare la dentro? Se continua a piovere così forte non so nemmeno se riesco a tornare a casa dice uno degli uomini che fissa lo sguardo nel nulla davanti alla finestra. Un infermiera entra nella stanza e con voce ferma senza inflessioni pronuncia un cognome, sono io! esclama qualcuno dal fondo della stanza. Ci siamo.
Giorno
La luce è ancora lontana anche oggi, mi piace molto veder nascere il giorno, mi riporta indietro ai tempi dei tropici, quando il sole nasceva e moriva in un battito d’ali, si sentivano i bambini urlare ice kendy per le strade di pece con la loro scatola di polistirolo a tracolla, il vicino era già sveglio accovacciato sul bordo della via che accarezzava i galli, un amore crudele di sangue e colori sgargianti. Ognuno iniziava ad apparecchiare sulla strada i suoi due metri di fronte a casa, un vecchio telo rammendato come tovaglia steso con cura senza pieghe ricoperto di riso da far seccare, di cesti intrecciati di foglie di cocco pieni di granchi appena pescati, di pesci secchi appesi come calzini e paradisi di frutta sconosciuta dolce e succosa che ti invitava all’ozio sotto il silenzio del caldo. Anche se il giorno non era ancora nato la strada con la sua gente raccontava una storia che doveva ancora accadere, si certo sarebbe stato un giorno come tanti altri, ma quell’inventario metteva chiunque di buon umore e se mancavano pochi giorni al fine della settimana, i ragazzi pregustavano quelle ore preziose passate in cerchio a veder ballare fanciulle ornate di fiori, risparmiavano tutti i giorni per poter mettere un soldo nel cappello e invitare chi gli faceva battere il cuore.
E’ già giorno, il caffè gorgoglia insieme alla voce di Nilla Pizzi che canta come un edera avvinghiata si stringe nelle braccia del suo uomo, la prima sigaretta scompare è come se non l’avessi neanche fumata e penso a quanto egoismo c’era una volta nell’amore quanto oggi è rimasto.

La ghigliottina da frutti acerbi
Il gatto non parla inglese, o forse lo sa così male che si vergogna a parlare. Sta li nell’angolo a sistemare i suoi legnetti, ha gli occhi grandi e la pelle brunita, porta vestiti bianchi ricamati perché è l’unico modo per ricordarsi del suo paese lontano, Siri Lanka, Pakistan, India, non l’ha mai detto da dove viene del resto. La volpe perde pelo ma non se ne cura affatto, gira spavalda tra le collezioni di vecchi fumetti e ritratti a carboncino. Non è di Parigi, vive dove la Senna arriva al mare in una di quelle piccole case di marzapane che è difficile distinguere una dall’altra. Cialtrona e perennemente impataccata, la volpe vive di poco nei periodi di magra e quando riesce a sgraffignare qualche banconota profumata fa la signora lasciando mance sproporzionate. Quando gli ho detto che gli avrei mandato la mia biografia, si è messa a ridere e con quel modo un po’ viscido di chi fa finta di essere amico mi dice che non sarebbe stato certo un problema e che forse l’avrebbe scritta lei al momento inventando qualche baggianata. Entrambi sanno che vengo dall’Italia, ma per qualche ragione sconosciuta mi considerano russo a tutti gli effetti. Il signor Burghignon sembra essere molto amico della volpe, ridono e scherzano e quando si incontrano sovente capita che iniziano a fare uno strano balletto entrando e uscendo dal cesso dove sono esposte targhe e riconoscimenti falsi. Burghignon ama scommettere alle gare di salto col sacco, si considera un grande esperto quando si deve indovinare il peso esatto di un tacchino e non è mai stato con una donna. È pallido e unto e porta un paio di occhiali dalla montatura ovale un po’ storti forse per vezzo o sbadataggine. Tra gli assidui frequentatori dell’atelier dell’incoerenza c’è un anziana signora, lei non si interessa di arte viene solo per scroccare un bicchiere di vino che beve come se avesse appena finito di attraversare il deserto. Attacca discorso con tutti e la sua sete atavica è direttamente proporzionale alla sua solitudine. La volpe è a conoscenza delle puntuali visite della anziana signora e quando gli passa nei pressi la scaccia come si fa coi piccioni. Ci sono due scale a chiocciola nell’atelier quella che scende porta al magazzino di vecchi libri usati, quella che sale porta a una stanza misteriosa che quando chiedo cosa c’è la volpe risponde in maniera evasiva con risposte sempre diverse. Ogni volta che torno a Parigi inevitabilmente passo davanti all’atelier e mi meraviglio sempre che siano ancora lì come se il tempo non li avesse minimamente scalfiti.
Mademoiselle Coquerelle
Data di nascita, la prima lettera del tuo nome e forse qualche cosa che scegli all’ultimo momento senza quasi un motivo apparente, la porta si apre automaticamente, riconosce chi sei anche se non sei tu. Nell’atrio si intuisce il passaggio di messi comunali, operai a cui non si può chiedere di più di quello che sono tenuti a fare e gli inquilini che si confondono con chi esce e non tornerà mai più. I gradini che portano ai piani sono bassi, sembrano più comodi ma dopo la prima rampa ti rompono il passo. Sono dello stesso legno che tengono insieme le rotaie dei treni, sfibrato consumato dal continuo andirivieni. Al piano un lungo segmento mal illuminato da accesso ai vari appartamenti, c’è una porta socchiusa, ha un etichetta adesiva in parte strappata dove è scritto in stampatello Coquerelle. La luce delle scale dura poco, qualche minuto forse giusto il tempo per arrivare quassù, al buio riconosco chi è in casa e chi è fuori, la luce filtra da sotto le porte e si perde nell’oscurità. Ho una piccola pila da ciclista in tasca, ha un filo elastico fatto per cingere la testa così da avere le mani libere. La porta non oppone resistenza, basta un invito e ruota verso l’interno. L’appartamento è composto da due piccole stanze e un atrio adibito alla cottura, il soffitto basso, le pareti esili e le porte che sembrano tagliate a traforo danno l’impressione che sia una casa giocattolo. La luce coglie ogni singolo oggetto sparso, tavolette di cioccolato al latte, una pigna di piatti dal bordo dorato, un materasso appoggiato al muro, lenzuola mai usate e vestiti sobri che non dimenticano il lutto. Un foglio di una rivista da parrucchiere è attaccato alla parete, è la foto di lady D incoronata da un sorriso ignaro. Vicino su una mensola ricoperta di carta ingiallita un souvenir della torre Eiffel e una scatola di medicine ancora intatta mi fanno pensare che quello che valeva la pena di esser portato via non c’è già più. Metto velocemente nel sacco ciò che ridarò alla vita il resto lo lascio a chi dovrà liberarsene.
Regole naturali
Sono inseguito da insetti voraci, scappare non serve mi raggiungeranno prima di pensare di essere salvo. Perchè gli insetti hanno questo grande potere di spaventare le persone? Non è il fatto di essere armati che li rende così terrificanti, ma questo recondito pensiero che è in ogni uno di noi, è una sensazione di ribrezzo e terrore, di sporco e di qualcosa di malsano, forse è la paura di essere divorati da morti. Fatto sta che questi piccoli animali se ne approfittano, capiscono la nostra debolezza e diventano insidiosi e prepotenti. Quante volte associamo agli insetti situazioni negative, basta pensare a un ragno che tesse la sua tela, l’inganno. Il volto di un bambino africano fa molta più pena se ha una mosca sul viso. La formica nella propria laboriosità ci fa pensare a una struttura gerarchica crudele e diabolica. Questi piccoli avvoltoi in miniatura sono il frutto delle nostre angosce e del nostro malessere, viviamo con loro e grazie a loro, a questo enorme lavorio invisibile e instancabile che compiono giorno dopo giorno trasformando la materia, usando quello che non serve e dargli una nuova vita e così all’infinito. Possono percorrere migliaia di chilometri ma la loro vita dura pochi attimi, forse è per questo che si danno così da fare. Anche noi visti da degli uccelli che volano alti nel cielo potremmo sembrare piccoli insetti. Anche i pesci sono degli insetti ma vivono nell’acqua e per questo hanno caratteristiche diverse ma svolgono lo stesso compito con saggezza e costanza. I pesci sono muti perchè la loro conoscenza è così grande, la loro storia così antica che non hanno bisogno di comunicare niente. Ora un pesce mi sta guardando dal mio piatto, poco fa l’ho visto vivo sguazzare nell’acqua. Penso mangiandomelo alla sua vita di pesce, e sono contento perchè so che mangiando lui, lui diventerà me, così anche io posso diventare un pesce e questo pesce sarà mangiato da un altro uomo che sarà divorato a sua volta, forse da un pesce enorme. Si ride qui accanto. Penso che ridere, il rumore di una risata è come un richiamo di un uccello, è quello che ci resta del nostro istinto. Sarebbe bellissimo comunicare ridendo, il metodo è un po’ sconveniente perchè come tutte le cose spontanee sono incontrollabili. Noi invece siamo così attenti a sembrare quello che in realtà non siamo perchè l’apparenza è quello che attira di più. Ma l’apparenza è un inganno, è uno stratagemma che si ritorce contro colui che inganna. Piangere ridere sono sentimenti veri e talvolta, per la loro essenza vengono accolti con paura e diffidenza. Anche gli uccelli sono dei pesci ma hanno una conformazione diversa perchè vivono liberi nell’aria, cerco da tempo ormai di calpestare la loro ombra che viaggia veloce per terra, non è facile, ma un giorno ci riuscirò, e allora potrò volare. Gli uccelli hanno una dote sempre invidiata, quello di poter vedere il tutto da un’altra prospettiva, una visione di supremazia e di potenza. Sono degli esseri sovrannaturali. Tutti li mangiano pensando così di acquistare le loro preziose doti, ma pochi riescono a trovarne i frutti, il peso del loro corpo è così minimo che la forza del vento li porta lontano lontano. I loro itinerari sono rotte indecifrabili. Anche i sassi hanno una loro anima e quando cadono fanno male. Spesso dentro i sassi c’è un anima di qualche creatura remota che vive immobilizzata da secoli, la sua prigione è la sua salvezza, è una cosa che non ha bisogno di niente. È un flusso di vita che vive di una propria essenza misteriosa. Le piante sono i capelli del mondo senza di loro nulla esisterebbe, ecco perchè gli uomini sono così preoccupati di perderli, ma ogni capello ha un anima e necessita di cure assidue e amorose. I capelli della terra sono gli esseri più longevi che esistono, se potessimo comunicare con loro sono sicuro che la nostra vita migliorerebbe moltissimo, ma bisognerebbe diventare delle piante per poter far tesoro dei loro misteri e non tutti sono disposti a farlo.

I funghi
Una strada alberata contornava i prati verdi, sull’orlo quattro faraone cercavano in terra cibo vivo. Era una splendida giornata di settembre, dopo una discesa entrai in un bosco. I pini e le querce erano alte e lo sguardo si perdeva in un intricato disegno. La luce filtrava con segni bianchi in diagonale e illuminava a sprazzi. L’erba era molto alta ma rada, il fogliame un letto soffice sul quale camminavo silenziosamente, sentivo l’odore della corteccia umida, dell’erba calpestata, della terra ricoperta di rugiada. I grilli mi aprivano la strada e io camminavo senza meta prima avanti poi a destra poi un po’ indietro guardando questo mondo terreno straordinario. C’erano dei tronchi distesi ricoperti di muschio verde vellutato, sembravano dei relitti abbandonati da tempo immemorabile. Sentivo sotto i piedi delle ghiande sparse per terra, foglie marroni, rosse, verdi, erano colori in perfetta armonia con il paesaggio. Era bello camminare lasciandosi trasportare da miriadi di particolari preziosi. Nelle mani scorrevano le spighe d’erba, ora mi accarezzavano il palmo, ora le sfioravo col dorso. C’erano dei sentieri che si diramavano nel bosco per poi finire nell’erba, erano i percorsi di chissà quante persone che come me si lasciavano ingannare da un gioco di luci, da delle ombre accennate, da colori accesi e tenui sfumature. Feci un passo e incontrai un fungo nascosto dagli aghi di pino, anzi è lui che aveva incontrato me. Mi chinai, lo guardai e lo raccolsi pulendolo accuratamente. Bello, slanciato e sodo, la cappella scura leggermente vellutata mi fece venire un tonfo al cuore. Misi il mio prezioso bottino nel cesto e perlustrai la zona dato che loro stanno, si sa, sempre in compagnia. Trovai subito il compagno, poi un altro e un altro ancora. Mi precipitavo pensando quasi che mi sarebbero scappati da un momento all’altro. Avevo voglia di urlare “li ho trovati!” ma invece mi guardai intorno furtivo nel silenzio, presi delle foglie di castagno e ricoprii bene, in modo che nessuno potesse vedere l’oro che avevo trovato.
Partenze
Ho perso il treno. Sono arrivato quando ormai era un punto in fondo a due linee. Mi giro e guardo il grande pannello delle partenze. È nero e le lettere sono composte da dei cartellini che girano su se stessi fino a quando non trovano la lettera giusta. Ogni tanto i cartellini girano tutti insieme e in quel momento si sente nell’aria un atmosfera diversa. Sembra una cascata di lettere, alcune si fermano altre scivolano via. Coloro che aspettano di partire sono attenti a rintracciare il proprio treno, vedere su che binario parte, quanti minuti porta di ritardo. Spesso succede che uno di questi cartellini continui a girare cercando la lettera mancante, una variabile impazzita che sconvolgerà la partenza di molti. Il cartellone delle partenze scioglie quel cumulo di gente in attesa e la smista per essere proiettata verso la destinazione. Il treno per Agrigento per esempio parte dal dodicesimo binario, la gente si sposta con grosse valige in corrispondenza di quanto segnala il cartellone, ma questo, quando tutti sono lì ad aspettare, cambia il numero, così i passeggeri affannosamente si spostano al terzo binario attraversando tutta la stazione. Dopo pochi minuti il pannello segna di nuovo il dodicesimo, tutti si guardano disorientati e imprecando corrono in cerca disperata del loro treno. Altri treni sembrano facciano a gara per accumulare più ritardo. La rassegnazione si colora sui volti già stanchi dei viaggiatori, camminano su e giù nervosamente, alcuni fanno capannello protestando, altri in coda aspettano sperando in una alternativa. Una donna in cinta con due figli piccoli che gli ronzano intorno guarda il nulla mentre un elegante uomo d’affari le sfreccia davanti correndo, il suo treno ha già chiuso le porte e rimane in quel segmento di attesa del fischio. Si sente l’altoparlante annunciare il numero di un convoglio fantasma, la voce automatica gracchia qualcosa di incomprensibile il passeggiare di guardie avide di dettagli insoliti si intensifica. Scendo le scale verso l’uscita della stazione sorridendo, a casa so chi mi aspetta, faremo la spesa insieme.
La lode
A quell’età si è un po’ tutti scalmanati, e quando la maestra si rivolse a Gasperini, lui si aspettava di essere ancora redarguito per la sua esuberanza, ma Molgora, il compagno di banco malvagio, parlò per lui dicendo con una cantilena strascinata: “Maestra Gasperini ha scritto una poesia”, Gasperini diceva di no, che non era una poesia soltanto uno scherzo, uno scarabocchio sull’ultima pagina del quaderno e intanto divampava sentendo l’eco dei compagni che ridevano. “Vediamo”, disse la maestra, “se hai scritto una poesia la reciterai ai tuoi compagni”. La poesia s’intitolava “Le Rovine”, Gasperini in un momento senza senso aveva pensato che le rovine rappresentavano il rimpianto di qualcosa che più non è. Una rovina dimenticata da tutti meno che dal tempo paziente, che ruba poco ma sempre. La maestra si fece dare il foglio da Gasperini e rileggendola a mente si fermò un momento, quel momento dove tutto rimane immobile. “È, una bellissima poesia Marco, l’hai scritta tu?...Bravo! adesso vai a farti dare la lode in direzione!”. Gasperini uscì dall’aula preoccupato stringendo il foglio in bella della poesia. Si guardava il fiocco blu moscio come una petunia sfiorita, le patacche sul grembiule e poi lui in direzione non ce l’avevano mai mandato, bussò alla porta e aspettò qualche minuto, poi la porta si aprì e uscì un Maestro. La segretaria chiese cosa voleva e lui disse che era li per la lode, ma lo disse a bassa voce perché si vergognava tanto che lei non capì bene. Lo fece aspettare seduto in un angolo lanciandogli di tanto in tanto occhiate severe. Dopo un vuoto di tempo dove Gasperini correva tra il ticchettio della macchina da scrivere, e un particolare assolutamente uguale agli altri motivi di una carta da parati, all’improvviso si aprì la porta e uscì il direttore, Marco ricordava le sue bretelle come rotaie sulle montagne russe, puzza di sigaro e di polvere. “questo alunno cosa vuole?”, la segretaria si alzò e disse a sottovoce qualcosa al direttore che sentendo rispondeva digrignando gli occhi. Lo fece entrare in presidenza trascinato per un braccio. Il direttore era furente, e continuava a dire : è una cosa molto grave!”, scandiva le parole, le tirava come degli elastici per rafforzarne il senso drammatico. Gasperini era accusato di aver spalmato dentifricio sulle maniglie delle porte di numerose aule della scuola e visto il gesto enormemente grave avevano deciso di convocare all’istante i genitori. Marco atterrito riusciva a dire a malapena: “..ma io?...non…”. proprio quando le cose si stavano mettendo male, vide comparire d’incanto la sua maestra che lo cercava preoccupata non vedendolo tornare in classe. Gli sembrava un incantesimo vedere la sua maestra con quell’oceano di capelli rossi, quella collana tutta d’oro piena di cornetti, il suo profumo dolce e il sorriso buono. Subito spiegò al direttore il motivo per cui Gasperini era stato mandato in direzione e improvvisamente tutti si rivolgevano a lui con gentilezza, poi il direttore prese in mano il foglio protocollo un po’ stropicciato e lesse la poesia. ”È proprio una poesia magnifica!”, diceva il direttore inzuppando il timbro nel tampone. Un secco colpo del timbro sulla carta chiudeva per sempre quel patetico malinteso e Gasperini accompagnato dalla maestra tornò in classe. Al suo ritorno i compagni lo guardavano in maniera strana, come se avesse fatto una vaccinazione che gli altri non avevano bisogno. Quando suonò la campanella Marco preparò la sua cartella e una volta uscito dalla scuola buttò dentro un cestino la poesia. Ora si sentiva meglio, sembrava essere stato un giorno uguale agli altri e lui, finalmente era tornato ad essere come tutti i suoi compagni.
Barba
Camminava con l’umido tra gli occhi, la pioggia sparsa e il timido sole che si affacciava tra schizzi e vapori. Sembrava distinto ma non lo era, tanto che sui vestiti si vedevano i segni delle giunture per il consumo. Aveva un passo veloce ma indeciso come se stesse cercando qualcosa, una specie di scarabocchio sul marciapiede, che alla fine, vinta l’indecisione entrava dal barbiere come se avesse lanciato i dadi per l’ultima volta. Si sedeva aspettando il suo turno guardandosi intorno un po’ impaurito, un po’ per davvero e un po’ per gioco. Sulla destra, un piccolo acquario con dei pesci rossi lo incuriosiva, fissava i pesci con la coda dell’occhio, ma vergognandosi poi di divertirsi, si rimetteva in ordine per fissare il nulla. Il barbiere lo aveva già visto da un po’, sguardo affilato tra una sforbiciata al vento e un sorriso pietoso. “Se vuole me ne vado e ritorno dopo”, ma la mano con l’anello al mignolo faceva cenno di aspettare. Chissà se i barbieri si fanno la barba da soli o vanno da altri barbieri come gli psicanalisti, pensava già stufo di aspettare. Chiamato dal barbiere faceva finta di non intendere se era lui il prossimo, in fine si alzava a scatti per accomodarsi davanti allo specchio già avvolto dal bianco fino al colletto. “Come li facciamo?”, chiese il barbiere sottolineando le parole, come se stesse parlando con uno straniero. Poi non sentendo una risposta diceva, “corti lunghi? Mi dica lei”, con quel tono seccato di chi ha molto da fare. Ma lui pensava ad altro, ai capelli tagliati sparsi per terra come foglie secche, al profumo di una colonia di gioventù, a fiocchi di schiuma sospesi nell’aria. Si risvegliava al contatto di una mano sulla spalla dando l’ultimo scatto come una pila scarica, “tagliate tutto, fate di me un glabro!”, mentre radente allo stipite, il barbiere tirava il rasoio sulla coramella a strappo, si riaccomodava nei suoi pensieri. La barba, compagna di notti insonni a prender schiaffi dal fuoco o a nascondersi dal gelo, ultimo baluardo di saggezza impastato di vomito rappreso, ombra di un ombra, per restare per sempre invisibile. Mentre la schiuma ammorbidiva la pelle che per così tanto non aveva visto il sole, il barbiere si avvicinava e ripeteva quel gesto deciso ma dolce, come chi ti leva il cappotto quando torni a casa, la lama scorreva e svelava il disegno di un volto sepolto nel rimorso, fra i giornali che fanno finta di tenere caldo per volare via, il relitto di una scatoletta vuota, la confusione di chi cammina, di chi ha fretta, di chi non sà dove stà andando, di chi trascina quello che gli è rimasto e quello che si può ancora permettere di avere. Poi all’improvviso si alzava nauseato dell’immagine riflessa, pagava e usciva senza salutare. Si fermava subito dopo rubando il riflesso della vetrina per sistemarsi una barba posticcia, sembrava ridicolo, solo lui sapeva di essere il sovrano.


Orologio della morte
Era un lavoratore instancabile, passava la sua vita a scavare, solo, nel buio immenso, affannosamente corrodeva, triturava materia fino a renderla polvere così fine da diventare un letto soffice dove rannicchiarsi e sentirsi a casa. Di case, lui, ne aveva avute tante, una al giorno per l’esattezza, non c’era tempo di tornare indietro in quella della notte prima, bisognava andare avanti, sempre più in profondità, così di volta in volta si aggiustava sul posto come meglio poteva. Sarebbe stato meglio dire che tutti quei chilometri scavando cunicoli, tutte le biforcazioni, le vie d’uscita, le prese d’aria, i depositi, le scorciatoie, tutto era casa sua. Era così grande e in continua costruzione che per lui solo, sembrava proprio sprecata. Fu così che un giorno, mentre si era fermato un momento per riposarsi, aveva sentito dei rumori provenienti proprio dal punto dove stava scavando. Ogni tanto sentiva dei rumori che provenivano dall’esterno ma erano lontani come se facessero parte di un altro mondo. Questo no, era vicino e ben distinguibile, sembrava l’eco del rumore che faceva lui scavando. Si mise subito a scavare affannosamente nella direzione di quel rumore, ogni tanto si fermava per ascoltare, e proprio quando il silenzio riempiva lo spazio, anche dall’altra parte non si sentiva più niente. “Forse chi è dall’altra parte mi sta ascoltando come lo sto ascoltando io”, disse fra se e se. Scavò così tanto che gli sembrava di divorare muri giganteschi, fino a che non vide qualcosa muoversi. Capì che non era più solo e che se aveva potuto creare un opera così grande, in due sarebbe stata immensa. Da quel giorno la sua vita cambiò, non vivevano ogni istante insieme, ognuno scavava nella sua direzione ma alla fine della giornata, o per lo meno quando erano così stanchi da doversi riposare, si ritrovavano nello stesso posto, vicini nel mondo del buio. Ben presto nacquero molti figli, non era preoccupato, spazio per loro ce n’era e anche se non fosse bastato era facile fare crearlo. Ormai i cunicoli erano diventati un via vai continuo e tutto sommato non gli dispiaceva vivere insieme agli altri, anzi, sembrava essere più allegro e motivato nel suo lavoro. Sembrava che tutto ora, avesse un senso e visto che i figli forti e pieni di entusiasmo scavavano senza sosta, lui ormai alle porte della vecchiaia, si godeva il meritato riposo. Con gli anni i figli ebbero a loro volta altri figli che si spinsero, scavando, verso zone ancora sconosciute. “prima o poi non rimarrà più niente da scavare” pensava il vecchio patriarca che ormai si muoveva a fatica. Fu proprio in quell’istante che un boato secco, come un esplosione risuonò nei cunicoli. Tutti si fermarono ad ascoltare mentre i soliti rumori sordi dell’esterno sembravano continuassero come se non fosse capitato nulla.
Era la notte di Natale e proprio quando venne appoggiato un enorme tacchino ripieno sulla tavola, si sentì uno scricchiolio, subito dopo il tavolo crollò su se stesso come un edificio demolito, lasciando attoniti gli invitati.
Bologna 2021 "noti per i loro richiami sessuali (il picchiettio detto orologio della morte)"
Creazione
All’inizio erano in due ma ben presto se ne aggiunsero altri tre. Maestosi e infinitamente vecchi, ognuno sosteneva animatamente di essere Dio. “ Io posso vedere” scrisse su un foglio uno di loro, perché non poteva parlare. “Io posso sentire” disse un cieco. “Io posso toccare e guarire” disse l’altro sulla sedia a rotelle. Così come per il gusto e l’olfatto, ogni Dio si animava disquisendo su chi fosse il più importante. Poi il Dio dell’udito disse: “Uniamo le forze e plasmiamo il Dio unico che ci guiderà”. Allora, senza farsi vedere, lasciarono cadere un oggetto che in breve tempo assunse le dimensioni di un corpo. Lo massaggiarono, lo articolarono, regalando quanto di più prezioso avessero, fino al giorno che il grande Dio si svegliò e disse “voglio una donna”. I vecchi si guardarono sorpresi e dopo un breve consulto decisero di andare dal Dio del tuono che forgiò una forma che presto assunse le sembianze di una donna candida e fresca che si unì al grande Dio. Diedero alla luce due bambini, maschio e femmina che crebbero e presto si unirono dando alla luce un bambino che diventò il Re dei Re; ma aveva un difetto: era terribilmente pigro e presto si ammalò. Attraverso il dolore e la sofferenza divenne molto saggio e un giorno decise di creare il mondo. Lo fece per lui e i suoi figli e i figli dei suoi figli ma ben presto si accorse che quello che aveva creato era una massa sterile senza vita. Chiamò così il Dio dell’acqua che stava in cima a una montagna grondando di rugiada e dopo un po’ di discussioni lo convinse a dare acqua alla terra. Nei giorni seguenti iniziò un lungo periodo di piogge che continuò per molti mesi. Con l’acqua venne la vita ma il Dio degli Dei non era ancora soddisfatto. Decise di chiamare chi potesse colorare la terra. Il primo che arrivò fu il Dio rosso che estrasse una piccola boccetta di colore e fece cadere qualche goccia, in pochi attimi colorò la terra. Poi arrivò il verde che con un grosso pennarello colorò foglia per foglia e quando finì le foglie iniziò con l’erba. Al Dio blu bastò dire: “BLU” che tutto il celo si illuminò e corse via ridendo. Il Dio giallo portò il calore del sole e tanti fiori. L’ultimo ad accorrere alle preghiere di Dio fu il nero. Era un vagabondo vestito di stracci sporchi di fuliggine e al posto degli occhi aveva due grossi buchi neri. Sputò per terra e la notte per la prima volta si affacciò dando il cambio al giorno.
Baita Cross
Uscendo dalla roulotte c’è una cassetta rovesciata appoggiata per terra, è un comodo gradino, ma a volte quando il sole arriva fin qui mi ci siedo sopra e guardo dritto davanti a me fin che l’ombra non arriva. Di fianco c’è una piccola strada in piano che porta verso la cima del colle dove si unisce a una vecchia via militare che congiunge una valle con l’altra. Scendendo, prima di arrivare a un bivio c’è un grande cancello con un cartello tutto arrugginito dove si intravede una scritta a mano che indica la chiusura settimanale. Le bandiere montate sui pilastri sono ormai talmente scolorite che potrebbero essere di qualsiasi paese e in fondo a un grande slargo c’è il bar, ristorante, pizzeria Baita Cross. L’entrata è in uno stile misto texano - piemontese, le pareti del lungo corridoio che dà l’accesso al bar sono rivestite in legno, c’è poca luce e si ha la sensazione di trovarsi in una taverna di dubbio gusto. “C’è nessuno?” chiedo quasi voltandomi per tornare indietro. Una luce si accende, sento dei passi lenti che mi vengono incontro. “Mi dica” risponde una donna di età indefinibile. “È possibile mangiare qualcosa?” chiedo timidamente mostrando un debole sorriso. “Certo, si accomodi in sala”, apro una porta a vetri smerigliati e mi trovo in un enorme salone, tutti i tavoli sono perfettamente apparecchiati, non c’è un anima viva. “Dove mi metto?”, “dove vuole”, scelgo un tavolo al centro da quattro, mi tolgo la casacca e mi siedo. Passano alcuni minuti e nel silenzio più assoluto osservo questo posto surreale; mi viene in mente quel famoso albergo popolato da fantasmi. Sento ciabattare piccoli passi frenetici alle mie spalle ed ecco la stessa donna che toglie i coperti in eccesso, le sue mani sembrano quelle di un uomo, un piccolo ciuffo attaccato alla fronte, occhi spenti di chi ha visto troppa televisione. “Desidera un antipasto?”, “si” rispondo entusiasta, “di primo le posso portare una pasta. Come la preferisce al burro o col sugo?” ho un momento di indecisione. “Al burro” dico mentre penso ai sughi di mia nonna che si riciclavano per intere settimane. “La vuole al burro” sento dall’altra parte della parete, sorrido. Nell’attesa guardo un quadro che raffigura un enorme ananas, i coni dei tovaglioli immacolati sui tavoli, il grande camino spento e una pianta di orchidee. Arriva l’antipasto, una composizione ordinata ma senza pretese di pancetta del prete, un piccolo mucchietto di inalata di pollo con maionese guarnito da mezza noce, del salame cotto, dell’arrosto freddo con salsa di tonno. Il pane è croccante e caldo, l’acqua frizzante come non l’ho mai sentita. Pulisco bene il piatto con una scarpetta appropriata e guardo le tende di nylon bianco che filtrano il debole sole di novembre. Il primo arriva direttamente in padella, “questa è tutta pasta fatta in casa da noi” mi dice con un tono orgoglioso la donna mentre mi carica il piatto. “Di secondo abbiamo il coniglio con le carote….”, aspetto un’alternativa ma la vedo imbarazzata, “va benissimo il coniglio”. Nell’attesa mi vengono in mente tutte le strane voci che circolavano su questo posto anni fa quando è rimasto chiuso per un po’. Alcuni dicevano che davano gatti da mangiare ma non ci ho mai creduto anche perché qui in campagna servono molto e non ci si può permettere di mangiarli. Poi si diceva che la domenica quando la gente veniva a ballare ci si scambiava i bigliettini. Bevo un caffè e mi infilo velocemente la casacca, “era tutto squisito, quanto le devo?” . Esco, un cane con gli occhi languidi mi annusa i pantaloni, guardo l’orologio e penso, sono sole le dodici e mezza!
Luogo: imprecisato, Data: non rilevante
Las Ramblas
I giullari raccoglievano curiosi perditempo, i lustrascarpe, denti bianchi e mani nere, sedevano sulla poltrona aspettando il domenicale vestito a festa. Si sentivano i canti accesi di stormi nascosti fra le fronde degli alberi allineati come soldatini in vetrina. Un palloncino perso diventava un punto rosso su un foglio liscio senza nemmeno una nuvola, gli uomini accompagnavano le loro ombre a passeggio, le seguivano giù fino al mare dove scomparivano nella melma oleosa protetta da massi giganteschi in ordine sparso. Affacciate alle finestre donne grasse ridevano fragorosamente, odori di sughi tirati si liberavano dalle cucine dai muri intossicati per miscelarsi a quell’aria che pizzica il naso. Le bandiere a riposo dell’ufficio comunale erano tutto quello che rimaneva dell’autorità, erano cotte dall’aria salmastra e il loro stato dimesso non dava certo una sensazione rassicurante. Nel porto i pensionati guardavano i movimenti delle gru che caricavano le navi, il vento era scomparso ormai da giorni e quella calma stagnante sembrava una cartolina sbiadita destinata alla soffitta, perché è sempre meglio tenere piuttosto di buttare. I bambini nascosti male aspettavano il momento giusto per correre a liberarsi, mentre quello che li cercava non sapeva bene dove andare e si grattava la testa sconsolato. Mendicanti tremolanti ripetevano il copione di una vita sfortunata, le zingare invece sfoggiavano i colori della libertà con la fierezza di chi viene da lontano. Gli uomini seduti in fila fuori dal bar si accanivano in discussioni sportive dimenticandosi della propria pancia dilatata dalla sedentarietà, bevevano forte e non fermandosi mai lasciavano sul conto quel poco che restava della paga settimanale. Il sole allungava le ombre delle case delimitando la nitidezza dei contorni, presto la notte avrebbe calato il suo sipario silenzioso e la strada ripulita dai passeggiatori solitari si sarebbe fatta accarezzare dalle lunghe scope degli spazzini.
Barcellona 1990
Passaggi in automobile
Parlavamo tutti la stessa lingua ma non ci si capiva molto. Questo farebbe pensare a una frustrazione imbarazzante, a uno stato d’animo che impedisce ulteriori tentativi di avvicinamento, come quando la porta di un ascensore si chiude automaticamente al piano sbagliato. Invece tutti sembravano divertiti da questa insolita situazione, era il gioco di mettersi nei panni degli altri senza levarsi i propri, e chi del resto è disposto a rimanere nudo non sapendo nemmeno se i vestiti dell’altro gli vanno bene. Le conversazioni animate pulsavano, a volte un particolare dell’altro sembrava un appiglio per aggrapparsi, ma quando si arrivava vicino, protesi nell’afferrarlo, le parole uscivano dal finestrino risucchiate dal turbine della velocità. Il caso a volte crea combinazioni bizzarre e tutti eravamo consapevoli che a quel punto valeva la pena farsi accompagnare dolcemente piuttosto che opporre resistenza. Il primo passeggero, proprietario dell’autoveicolo era avvolto da un disordine apparente, un vezzo per nascondere l’insolenza di essere troppo attento e preciso. Le sue domande, camuffate da una spavalda cialtronaggine, sembravano messe li a caso, senza pensarci, ma per come erano attentamente formulate e poste all’interno della discussione, rivelavano un preciso schema d’intenti. Il secondo passeggero spalleggiava la sagacia del pilota come poteva, nei limiti di un uomo alla deriva, che davanti al baratro della disperazione racconta una barzelletta. Il suo mostrarsi brillante e simpatico stuccava come quelle torte colorate troppo, dolci che nascondono dissapori inconciliabili. Il terzo passeggero era un piccolo animaletto vivace e indipendente, una di quelle creature che anche fuori dalla propria tana si muove con estrema disinvoltura, stava al gioco senza irrigidirsi, anzi, aspettava che le parole gli venissero incontro per schivarle rimanendo fermo sulla propria stabile posizione. Sembrava uscito fuori da un mondo microscopico, un’inezia senza confini, e quando i benpensanti di ampie vedute si accorgevano di lui restavano smarriti, come se si fossero improvvisamente resi conto di vivere in uno spazio mentale angusto e pieno di preconcetti sottintesi. Il quarto passeggero, una ragazza impegnata a raggiungere i vertici dell’omologazione sociale, si liberava i lunghi capelli riccioluti da un ipotetico e fastidioso scompigliatore, un suo amico immaginario che conosceva dall’infanzia. Sembrava sapesse benissimo quello che doveva ancora succedere e l’espressione annoiata ne dava conferma. L’ultimo passeggero ero io, scomodamente in bilico tra un sedile e un altro, ascoltando distrattamente il tempo che mi avrebbe portato all’arrivo di una nuova partenza.
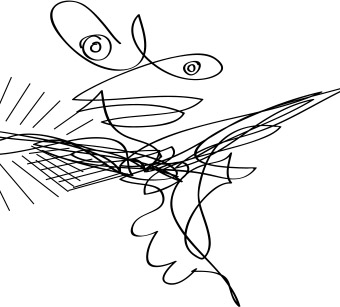
Naufragio e la salvezza
Naufragio e la salvezza; mai come ora queste due parole sono state così vicine, concatenate ma allo stesso tempo lontane perché trattenute dal destino. Avrei potuto forse vivere una vita tranquilla fra i rassicuranti muri di una quotidianità vuota e inutile? Chi determina la mia vita? Sembra un gioco di specchi, quelli che si trovano nei Luna Park, un caleidoscopio del se, eppure qualcosa mi dice che non poteva che andare così. Non tutto si può raccontare, c’è un limite oltre il quale è meglio non addentrarsi, verresti preso in giro con fragorose risate, di quelle che trattengono il respiro, o forse insultato, picchiato, poi, i segni del ricordo, le cicatrici intendo, sono libri che si aggiungono alla biblioteca, alla tua. Ci sono quelle visibili, indelebili e mutanti, ma così vive nella memoria, così presenti da riportarti nell’istante dell’accaduto in ogni momento. Che forma hanno le cicatrici invisibili? Il fatto che lo siano, le rendono enormi, e forse è proprio così che devono essere. Si poteva passare la vita a fotografare fantasmi, a cercare un insetto per dargli un nome, il proprio nome, un disperato tentativo di lasciare qualcosa. Potevo aver vissuto la mia vita come quelle che passano senza lasciare orme, fra la nebbia d’inverno in una stazione dimenticata?
Chiaroveggenza emotiva
A volte capita che tra un respiro e l’altro si incontra qualcosa che illumina il nostro cammino, sincronie magnetiche? Luminescenze chimiche? Energie meccaniche? Non saprei proprio rispondere, ma quello che mi colpisce è che ci si sente in apnea, senza peso, lungo la corrente della chiaroveggenza emotiva, e appeso a una maniglia ti lasci portare dal destino che ti accompagna dolcemente verso l’ignoto. Ma è anche vero che se le cose si pensano è perché devono ancora accadere e se la speranza è sorella del desiderio io sono il padre del mio passato. Poi tutto si mescola e si fa un po’ di confusione, si pensa di cancellare tutto ma le tracce riappaiono come fantasmi dispettosi. Quante volte ci siamo incontrati e non ci siamo mai visti? C’è tempo al tempo, sorrisi alle parole e un po’ di fatalità distratta. Rimangono le cose plasmate con le mani, il profumo di terra bagnata, un gatto che ti aspetta, e chili e chili di lavoro arretrato.


Notte di Natale
Era una stanza perfettamente quadrata e questo la rendeva più raccolta di tanti altri posti. L’atmosfera caramellata si riconosceva da quei dettagli rimasti vivi ancora adesso dopo tanti anni: la tappezzeria strappata con quei piccoli gigli che confondono la vista, il legno annerito del soffitto, il pavimento rivestito di scampoli di moquette di colori diversi, il camino che chissà se era mai stato usato e tutti quei trabiccoli per sognare grandi battaglie. Non era un giorno qualsiasi, la vigilia di Natale era imminente. I fiocchi di neve scendevano lentamente per cancellare il paesaggio, non si sentivano nemmeno i cani probabilmente acciambellati tra di loro in cerca di calore. Io ero li, in piedi sul baule con il naso all’altezza del davanzale della finestra mentre caricavo una vecchia scimmietta di latta gialla. Anche i colori quella sera sembravano diversi, caldi e morbidi come il velluto dei pantaloni del babbo. Nessun albero, nessun presepio solo una piccola stella di cartone appesa alla lampada della scrivania e un calendario con delle finestrelle da aprire ogni giorno. Fu proprio quando il mio giocattolo a molla si fermò che sentii il rumore della fuliggine appoggiarsi sul fondo del camino. Scesi dal baule con un salto e mi misi seduto a gambe incrociate aspettando li davanti. L’emozione nel vedere la corda che scendeva giù per la cappa fu tanta, ma quando vidi i grossi stivaloni di pelle, i pantaloni e la casacca rossa dissi dentro di me: ma allora esiste veramente! Era lui Babbo Natale in persona che con un sorriso mi porgeva pacchetti dai fiocchi sgargianti. Ci sedemmo al centro della stanza e iniziai impazientemente a scartare i regali, mentre lui soddisfatto si accendeva la pipa godendosi un prezioso momento di riposo. Fu mentre provavo a montare la ferrovia del trenino che vidi scendere dal camino un altro Babbo Natale, era perfettamente identico al primo e anche lui come l’altro mi porse i doni. Ne scese un altro e poi un altro ancora e in pochi minuti la stanza era piena. Tutti ridevano e facevano a gara per darmi il regalo più bello ma dentro di me iniziavo a sentire una strana angoscia che serpeggiava mentre una lacrima scendeva sulla guancia. Quando mio padre aprì la porta avvertendomi che la cena era pronta mi ritrovai da solo e con un balzo mi buttai tra le sue braccia, mi disse che dovevo mangiare in fretta perché poi sarebbe arrivato Babbo Natale.
Libera interpretazione dal film: “La cité des enfants perdus” di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, 1995
Paura di volare
Ho tutto in tasca, passioni e speranze che hanno fatto suonare l’allarme. Salgo su un esile scaletta, ed entro nella pancia di un volatile gigantesco, mi salutano cordialmente e prendo il mio posto vicino al finestrino. Amo le norme di sicurezza, quei gesti calmi che sono entrati nell’abitudine che precedono una catastrofe, li trovo eroticamente perfetti. Allaccio le cinture e sono pronto a volare, mentre guardo questo goffo animale che a terra si muove male. Un grande ruggito e si prende velocità, chiudo gli occhi e un respiro prende il volo come in un vuoto di una bolla di sapone, come un attimo tra sogno e realtà. In quell’attimo fuori tutto cambia forma e ciò che pensavo fosse infinitamente grande diventa un ricordo che si allontana. Da sopra tutto sembra più ordinato e mi viene voglia di giocare con quelle casette così bene allineate. Una voce gentile annuncia una pallida possibilità di turbolenze, sono dei vuoti d’aria che ti fanno scendere di centinaia di metri facendoti fischiare le orecchie. Mentre compenso mi danno da bere è un sorso a diecimila metri, il mio cuore batte forte, sono pallido e ho paura di cadere.
Che ore sono?
Ascolto lo scandire del tempo, ogni stacco della lancetta dei secondi segna un istante che è trascorso, un grido di paura, un pensiero svanito, un ricordo che rincorro disperatamente. La luce affiora anche oggi tra le case che ci contengono, segna l’inizio di un nuovo giorno che sarà uguale a tanti altri, che si confonderà come i secondi che vedo scandire inutilmente. La convenzione illusoria del tempo mi esorta a mettere le cose una dopo l’altra, in fila ben ordinate, quello che è stato, quello che è, vorrei tanto non dare un senso a tutto questo, confondere gli stati della mia coscienza senza preoccuparsi di vivere come tutti vivono. Le convenzioni, le abitudini, ciò che si crede di aver bisogno sono la prigione dell’anima, un anima schiacciata da questo tempo immutabile, da quello che si prova e che si dimentica troppo facilmente, perché tutto sembra essere uguale, sembra essere già vissuto. Siamo ancora troppo lontani per non dare così tanta importanza al tempo, la costrizione ci rassicura, raggomitolati nella nostra tana rassegnati fra il buio e la luce. Si muore per aver voluto difendere la schiavitù dell’abitudine, si muore senza un motivo lasciando piccoli simulacri inerti, si vive da morti guardando un programma televisivo, facendo finta di essere contenti.
Eppure si dice non è mai troppo tardi, come se ci fosse qualcosa che si allunga e si accorcia a nostro piacimento, una materia plasmabile, duttile che prende forma dalle nostre pulsioni, si ignora l’ineluttabile, si ignora che il tempo scorre indipendentemente da tutto quello che ci circonda, ma quello che ci circonda è il tempo stesso.
Un angelo per capello
Da che mondo è mondo gli angeli hanno sempre avuto i riccioli, forse perché lassù si scompigliano sempre i capelli. Ne ho conosciuto uno, caduto come un frutto pronto per essere mangiato, cotto dal sole, sembrava proprio come uno di noi perché una volta toccata terra aveva perso le sue magnifiche ali bianche. Si sentiva a suo agio e stava ben lontano dalle persone cattive, solo gli animali lo riconoscevano come anima pura e lo curavano come se fosse uno dei propri simili. Quando lo vidi per la prima volta ebbi la sensazione di conoscerlo da tanto tempo, non una sola parola, ne un gesto sembravano necessarie per esprimere l’enorme meraviglia, quello strano senso di triste gioia che ci invade senza preavviso, e come attaccati a un filo immaginario camminavamo insieme sopra le nuvole. Lo ritrovai appollaiato accarezzando un semaforo impazzito e me lo portai a casa come un regalo dimenticato. Mi sono sempre chiesto se la sua venuta fosse legata al caso o se tutto faceva parte di un preciso disegno, ma poi sorridevo colto ancora una volta a cercare i miei perché che affioravano in mente come pallide incertezze, così lontano da quella semplice immensità che rappresentava. Ma chiuso tra quattro pareti sembrava più un pollo di batteria che un angelo e dopo tanto pensare lo portai in campagna e lo lasciai nel bosco. Corsi via piangendo pensando di non rivederlo mai più e quando rientrai a casa me lo ritrovai stravaccato in poltrona attaccato alla televisione. Mi rendevo conto che era terribilmente attratto da tutto ciò che rappresentava il peggio delle abitudini dell’uomo e non mi meravigliai di trovarlo al casinò con valige piene di banconote fresche di vincita. Sapeva conquistare la fiducia e la simpatia di tutti e spesso lo vedevo tornare a casa ubriaco in compagnia di perditempo e fanfaroni che lo portavano sul palmo delle mani grazie alla sua infinita generosità. Fumava come un turco e una notte addormentato sulla poltrona, una sigaretta tra le dita cadde su una rivista, il fuoco avvolse la poltrona divampò su per le tende e ben presto fumo e fiamme distrussero il mio appartamento e quello dei vicini di sopra. Non rimase niente e fu l’ultima volta che lo vidi. Quando fui portato fuori dai pompieri una pioggia di piume bianche ricopriva la città, era passato per questo mondo come la neve che attutisce i rumori e piano piano si scioglie e riporta tutto all’innaturale normalità.

Coniglio Cappello
Era arrivato per posta in un giorno che
il freddo bruciava la pelle. Non era
un pacco voluminoso e anche il peso
era assai esiguo. Era legato da una
corda con un piombino attaccato e i
timbri erano stampigliati sulla carta
marrone che lo ricopriva. Non
c’era mittente e anche la calligrafia
con cui era scritto il destinatario
non era familiare. Con cautela mi
accingevo ad aprirlo, come quando
si gusta il proprio piatto preferito.
Una volta scartato, mi trovai davanti a una comunissima scatola da scarpe con dei piccoli fori sul coperchio. Chi poteva avermi mandato questa scatola? Nessuno sapeva dove mi trovavo, che cosa mai poteva contenere? Quando aprii il coperchio vidi un piccolo coniglio grigio che timidamente fiutava l’aria. Aveva delle orecchie grandi e la coda minuscola e il suo manto peloso era morbido e soffice come un cuscino di seta. Lo accarezzavo guardandolo con meraviglia mentre sentivo tra le mani il battito del suo cuore. “E tu da dove salti fuori?”, mi venne da dire sussurrando per non spaventarlo. Sentivo il calore del suo corpo irradiarsi in me. “Sei così morbido che se ti potessi tenere in testa, starei caldo tutto l’inverno”, dissi scherzando. Sarebbe stata una buona idea averlo sempre in testa, proteggerlo dai gatti randagi che sicuramente, prima o poi, l’avrebbero sicuramente mangiato. Proprio in quel momento il coniglio saltò e si accomodò sul capo come se avesse capito quello che avevo pensato. “Ma tu mi leggi nel pensiero”, dissi meravigliato. All’inizio faceva un po’ fatica a stare in equilibrio, ma ben presto si abituò e sotto gli occhi increduli della gente andavamo a spasso sotto la neve senza badare alle occhiate severe e alle risatine di scherno dei passanti. Quando pranzavo lo posavo delicatamente sulla panca e senza farmi vedere troppo, gli allungavo una foglia di insalata. Era un coniglio così bravo che raramente si muoveva, mi stava sempre vicino e quando era ora di uscire aveva imparato a saltarmi in testa da solo. Già dopo qualche settimana eravamo diventati molto amici, così decisi che era venuto il momento di dargli un nome. Ci pensai a lungo, ma tutti quelli che mi venivano in mente non mi convincevano. Alla fine decisi di chiamarlo semplicemente Cappello. La sera ci addormentavamo vicini tenendoci caldo a vicenda e il primo a svegliarsi era sempre lui, Cappello, che usciva da sotto le coperte e strusciava la sua morbida pelliccia sulle mie guancie ancora addormentate. Quando andavo a lavoro lo lasciavo dentro l’armadietto dello spogliatoio, “aspettami qui da bravo e presto tornerò a prenderti”, dicevo salutandolo. Era l’unico momento che dovevamo stare separati, lavoravo come aiuto cuoco e nessuno mi avrebbe permesso ti tenerlo con me anche in cucina. Un giorno, stavo godendomi il meritato riposo, la neve scendeva fitta e lasciava un manto brillante e puro. Ogni colore era sparito, solo il bagliore del bianco illuminava il giorno. Stavo seduto su una panchina a contemplare quello spettacolo dove ogni cosa sembrava essere stata cancellata, come se quel paesaggio che ricordavo fosse un pensiero dimenticato. “Ora davanti a me ho un foglio immacolato per rincominciare la mia vita”, pensai sorridendo. C’erano dei ragazzi che giocavano a palle di neve, ridevano spensierati e quando si accorsero della nostra presenza ci puntarono come bersaglio del loro divertimento. Non avevo voglia di alzarmi e andarmene, e considerando che erano lontani e i loro tiri erano lontani dal colpirci, rimasi seduto facendo finta di niente. Ma dopo qualche minuto fummo centrati in pieno. Cappello si spaventò tanto che corse via facendo dei lunghi balzi sprofondando nella neve. “Coniglio Cappello, torna indietro!”, urlavo rincorrendolo goffamente impacciato, ma Cappello era già lontano. “Come farò senza di te!”, dicevo sconsolato. Passarono mesi e con loro tutte le stagioni, la neve si era sciolta con i primi raggi di sole e il disegno della vita tornava a prendere forma. Le gemme vestivano i rami degli alberi di quel verde tenero e acerbo commovente. Spesso mi sentivo triste senza il mio amico che era comparso un giorno misteriosamente per poi scomparire senza averlo mai più visto. Fra vapori di sughi densi e arrosti bruniti, lo immaginavo libero e felice nei campi sterminati alla ricerca di radici prelibate e erbe selvatiche. Pensavo anche ai cacciatori, che da poco, come angeli della morte, battevano passo per passo la campagna in cerca di trofei. Pensavo ai falchi che volteggiavano alti nel cielo con il loro occhio rapace, vigili ad ogni più piccolo movimento. La primavera fioriva prepotente e sensuale, fiori di mille colori erano le note per gli uccelli che erano tornati dal loro lungo viaggio. Io cucinavo le primizie dell’orto componendo piatti che rappresentavano, con i colori e le forme, quel magico risveglio. Presto seguì l’estate con la sua calura sospesa portando sciami d’insetti che non davano pace. L’autunno melanconico con i colori tenui di una lenta agonia, il rumore delle foglie secche sotto le scarpe, i tramonti infuocati che illuminavano le montagne già innevate. Proprio in una di quelle giornate, al calar del sole, ero in cerca di legna per il forno del pane. C’era un grosso tronco che era finito per metà dentro un fosso dove l’acqua pettinava lunghe alghe verdi. Mi sforzavo in tutti i modi per recuperare quel grosso ramo fermandomi di tanto in tanto per riprendere fiato. Davanti vedevo la prospettiva dei pioppi allineati che si fermava ai limiti di un campo di riso. Avevo la strana sensazione di essere osservato. Ad un tratto un rumore di foglie aveva attratto la mia attenzione. Riuscivo a distinguere due grandi orecchie grigie che spuntavano dal violaceo fogliame. Rimasi immobile come pietrificato per il timore che solo un respiro potesse spaventare quella creatura. Solo quando si alzò sulle zampe posteriori annusando avidamente lo riconobbi, era il Coniglio Cappello. “Finalmente ti ho ritrovato. Dove sei stato tutto questo tempo?”. Mi stupii che dopo tutti quei mesi libero per i boschi non sembrava essere diventato selvatico. Si comportava come sempre e liberandosi dalle mie mani mi saltò in testa e si accomodò bene. Rimanemmo così per un tempo indefinibile, fino a quando iniziai a sentire il suo calore che si diffondeva dalla testa fino alla punta dei piedi. Ad un tratto ebbi la certezza che quel calore si stesse trasformando in emozioni visive. Era come vedere il paesaggio dal finestrino di un treno. Tutto mi appariva diverso, come se stessi vedendo da una nuova prospettiva e ogni cosa intorno sembrava essere enorme. Le foglie avevano dimensioni di un lenzuolo, un arbusto, un grande albero secolare. Anche gli odori mi sembravano più pungenti e definiti, il profumo della terra umida, del legno macerato sotto le foglie. Ma più di tutto era l’udito a essere amplificato all’ennesima potenza, il canto degli uccelli sembrava una sinfonia trionfale, il rumore di un rigagnolo, una fragorosa cascata. Sentivo un colpo di fucile in lontananza così forte da sembrare una cannonata. Presi Cappello, che ormai si era quasi appisolato e lo misi nella giacca per paura che fuggisse di nuovo. Mi resi conto improvvisamente che tutti i miei sensi erano tornati alla normalità. pensai di aver avuto un’allucinazione e mentre accarezzavo le morbide orecchie di cappello si divincolava cercando di uscire dalla giacca. Con un balzo aveva raggiunto la testa e tutto era tornato in quella strana dimensione magica. Presto capii che tutto quello che mi stava accadendo era dovuto al contatto del coniglio con la mia testa, vedevo con i suoi occhi, sentivo con le sue orecchie, fiutavo col suo tartufo. Quando presi conoscenza di tutto ciò, una voce, la sua, mi disse:”quando sono corso via, non era per lo spavento. Volevo vedere il mondo, essere libero. Ho corso molti pericoli, ho sofferto la fame, ho imparato a vivere, a contare sulle mie forze, a riconoscere le frontiere della mia anima, ad amare ogni più piccola cosa che mi circonda. Il vento mi ha dato la direzione, la pioggia mi ha insegnato a proteggermi e sapere aspettare, il sole mi ha illuminato col suo calore dandomi forza. Ora sono qui vicino a te, io vedo con i tuoi occhi, tu vedi con i miei, siamo uno nell’altro in ogni momento che lo vogliamo.

Il Vigile
Dopo tutti quegli anni di canottiere sbrindellate e scatolette di tonno tra le coperte, si era reso conto che qualcosa non andava. Fu un giorno qualsiasi, così qualsiasi che alla fine non lo era affatto. C’era bisogno di un po’ d’ordine tra l’incrocio di via San Tomaso e via Broletto. Aveva aspettato con impazienza l’orario di apertura del cartolaio, e quando aprì la bottega si fece avanti precipitoso tanto che spaventò il cartolaio, un omino bianco col vestito nero, polveroso come i suoi astucci. Lui invece era alto e grosso, la testa pelata e lo sguardo severo. “Ce l’hai un casco da vigile e una paletta? Si quelle dei bambini… Anche il fischietto, quello è importante!,”, - non credo-, disse il cartolaio sottovoce, poi si avvio dietro, quasi tra se e se, – forse nello scatolone di carnevale -. Non era rimasto li a guadare, pagò e uscì dal negozio con i giocattoli sotto braccio. Arrivato sul posto si mise al centro dell’incrocio, nel pieno del traffico mattutino di una giornata piovosa a dirigere il traffico. Molti all’inizio gli suonavano imprecazioni, una volta rischiò anche di essere investito, ma la sua costanza giornaliera aveva fatto si di riconoscerlo nella carica che non aveva, ridevano vedendolo con quel casco metà della sua testa, legato con lo spago per non farselo scappare. Aveva un modo tutto suo di dirigere il traffico, a volte addirittura faceva passare a turno una macchina alla volta, oppure si aspettava decine di minuti perché aveva deciso che doveva lasciar passare dall’altra via. Ma la cosa che complicava tutto era l’indecisione, l’imprevedibilità che bloccava l’intero centro città. Vennero infine i vigili, quelli veri, e lo portarono via, ma non passava una settimana che era già li. Ormai si era instaurato un rapporto di simpatia negli automobilisti, che quando lo rivedevano non suonavano più, ma ridevano. L’incrocio dove “dirigeva” il traffico era composto da due vie, la prima una viuzza sull’angolo di una chiesa chiusa, l’altra grande e trafficata con negozi e i tram che passavano suonando la campana. La questione diventò un bel grattacapo per il comune, tanto che il sindaco decise di mettere un semaforo. Fin che passarono quei giorni ad installarlo non successe niente, il che è un modo di dire, lui continuava a fare il suo dovere come se niente fosse. Ma quando il semaforo entrò in funzione fu un inferno, mentre era verde faceva passare quelli che avevano il rosso, e gli altri da dietro vedendo il semaforo suonavano. Non si sentiva un vigile ma un direttore d’orchestra, sventolava la sua palettina con le gote gonfie fischiando ad intermittenza. Anche quando non si vide più tutti se lo immaginarono a dirigere in qualche angolo della città.
Primo cassetto
Si gattona ancora tra i cuscini enormi e tutti colorati. I cavalli di zucchero con la striscia blu che gli gira intorno galoppano con quel ritmo sincopato. Ci sono dei treni che scompaiono sotto una pila di libri e ricompaiono scortati da schiere di migliaia di soldatini tutti uguali. C’è un gabbiano che muove le ali se c’è vento, ma le muove lo stesso anche se non c’è. Il sole ci guarda tutti i giorni, mette sale sulle case e illumina i tuoi occhi scuri. Ci sono intrugli di avanzi, pacciughi di noia nelle lunghe ore dopo i pasti interminabili. Pensavo di correre via giù per il prato poi mi sono messo a ridere, sono inciampato e mi hai preso e non mi hai lasciato più rotolando abbracciati in quel niente che è tutto.
il Dio dell’impermeabilità
Il Dio dell’impermeabilità passava il suo tempo in una scatola, non tanto perché non era impermeabile e aveva bisogno di ripararsi, ma perché gli altri, stufi di ogni sua totale mancanza di reazione l’avevano messo lì dentro pensando che ormai non c’era nient’altro da fare. Non mangiava, non beveva e qualche volta nemmeno respirava, l’ossigeno, seppur rarefatto gli dava fastidio in quanto entrando nel suo elementare organismo gli provocava reazioni emotive indesiderate. La noia era la sua unica amica. Molti lo paragonavano a una cipolla, dove sotto il primo strato impermeabile se ne trova un altro fino all’esaurimento di se stesso.
Quando arrivò sulla terra fece un grande tuffo nel mare. Si liberò dalla sua scatola tenendola stretta per galleggiare meglio. Non sembrava preoccupato di essere in quella distesa liquida senza confini, “tanto sono impermeabile”, diceva facendo spallucce. Il mare era calmo come olio in un ampolla dimenticata. Non sapeva bene se restare fermo in ammollo o scegliere una direzione a caso e iniziare a nuotare. Pensò a lungo e alla fine preferì rimanere dov’era aspettando la corrente che l’avrebbe portato da qualche parte. Si sentiva un po’ stupido così fermo in mezzo al mare, ma alla fine non gli sembrava una condizione così diversa dalle sue abitudini. Ma l’acqua è capace di insinuarsi lentamente anche nei soggetti idrorepellenti e quando trova una via inizia a scavare impadronendosi di tutte le certezze per scioglierle come lo zucchero nel te. Continuava a non scomporsi, sapeva che qualsiasi cosa fosse accaduta per lui non cambiava assolutamente niente. Fu verso sera che intravide lontano un piccolo puntino illuminato, forse una barca pensò. Agitò le braccia e l’equipaggio della barca con i riflessi del tramonto sul mare lo avvistò subito. Quando vide a pochi metri l’imbarcazione, si rese conto che era una carretta del mare con a bordo una folla di disperati partiti per raggiungere un sogno che era diventato un incubo. Quando fu a bordo vide gli sguardi devastati dalla paura, dalla stanchezza, dalla fame e dalla sete. Sentiva in loro la consapevolezza che sarebbero morti tutti, forse uno per volta lentamente, o forse tutti insieme quando quella barca sarebbe affondata. Pensava, non è un problema mio, cosa mi interessa di questa gente, neanche la conosco. Le ore trascorrevano nel silenzio, un silenzio cupo d’incertezza e paura, anche il Dio dell’impermeabilità non si sentiva molto bene, gli girava la testa e sentiva un senso di vuoto dentro che non aveva mai sentito prima. Il giorno dopo alle prime ore dell’alba scorsero qualcosa all’orizzonte. La terra ferma era ancora lontana, ma il solo fatto di intravederla dava speranza a quella gente stremata. Forse ce l’avevano fatta, forse alla fine della giornata avrebbero raggiunto terra. Ma nelle ore più calde del giorno, quando il sole implacabile bruciava la pelle arsa dalla salsedine, la barca s’incagliò in una secca e iniziò a imbarcare acqua. La falla non era così grande da mandare a fondo la barca, ma in pochi minuti si appesantì molto, e seppur svuotando l’acqua, la chiglia raggiungeva quasi il livello del mare. Bisognava prendere una decisione subito, una decisione drastica ma necessaria. Gli uomini senza dirsi niente, con estrema cautela si alzarono, abbracciarono le loro donne e i bambini rassicurandoli che si sarebbero ritrovati a riva e si buttarono in mare per togliere peso alla barca. Tutti sapevano che la riva era troppo lontana per raggiungerla a nuoto, ma quegli uomini erano contenti di sacrificarsi per i loro figli, sognavano che almeno loro avrebbero potuto avere una vita migliore e che questo viaggio assurdo alla fine sarebbe servito a qualcosa. Si alzò lentamente anche lui, gli occhi fissi su quelle teste in acqua l’aveva isolato per un attimo da tutto, in quel momento solo quegli uomini contavano per lui, voleva raggiungerli, essere con loro perché era giusto farlo. Voleva dirgli che in tutta la sua esistenza non aveva mai visto gli uomini e solo ora capiva che è molto più difficile essere uomo piuttosto che un misero Dio.
È vietato parlare al conducente
Si è smarrito nel risentimento
di essere preso per il naso.
Se solo lui potesse decidere
di sostituire un auto blu
con una bicicletta, tutto sarebbe diverso.
Dubbi condivisi non possono trovare soluzioni
in un così breve tragitto
Auto articolati
Fuori dal ristoro deserto
falchi appisolati
pesano il tempo
di chi passa dalla cruna di un ago.
La corrente rallenta
come il fluire lento
di un divieto assoluto
Stella di carta
Una piccola stella di carta
cade sul suolo dello scompartimento.
Si è sacrificata per accertare la meta,
lontana o vicina che sia.
Gemella di un biglietto senza ritorno,
ora si unisce al firmamento
di un cielo polveroso che solo a fine corsa
qualcuno pulirà
Gioventù del Dio ladro
Non ricordava dove aveva abitato perché i suoi genitori cambiavano spesso dimora. In quei delicati periodi di assestamento, veniva sempre il giorno che si doveva raccattare in fretta e furia le poche cose che c’erano e partire. Era inutile chiedere dove si andava, le priorità di scomparire in silenzio senza lasciare traccia mettevano in secondo piano qualsiasi scelta di una possibile destinazione. Non aveva giochi perché troppo ingombranti da portare in viaggio. Dormivano in albergo tutti e tre in un letto matrimoniale, ma aveva un sonno lieve interrotto dai fruscii di banconote sparse che si accartocciavano ogni volta che cambiava posizione. Viveva in una agiatezza temporanea, tutto gli sembrava così sfuggente da essere perfettamente consapevole, nonostante la tenera età, di non avere nessuna certezza nel futuro. La sua famiglia gli sembrava così diversa da tutte le altre. La sera prima di andare a letto guardava suo padre mentre si vestiva, sembrava che ogni sera dovesse andare a un matrimonio. Gli piaceva vedere quella cerimonia, la camicia bianca immacolata, i gemelli con i brillanti, nuvole di profumo e quel dilemma su quale cravatta scegliere, accostamenti cromatici, trame dei tessuti, per poi mettersi la prima che gli capitava. Vestito da cerimonia gli sembrava un Dio imponente, pronto a vincere mille battaglie. A volte lo rivedeva la mattina dopo, e aveva tutto un altro aspetto, la puzza di fumo intrisa nei vestiti, la camicia sgualcita, il nodo della cravatta allentato e quell’odore dolciastro di liquori fermentati nello stomaco. Si vedeva subito se aveva vinto o perso la guerra, gli si leggeva negli occhi. Sua madre cercava di dare una parvenza di normalità a quella vita a volte così in alto da credere di avere il mondo nelle proprie mani, a volte così in basso da ritrovarsi in ginocchio davanti al water a vomitare bile. Tutti dicevano che suo padre era molto bravo, certo, lui lo sapeva, ma in che cosa non lo aveva mai capito. Sapeva che era il più bravo e basta, il più bravo in tutto. Lo scoprì quando aveva tredici anni, gli fu detto dai figli di amici con cui viaggiavano insieme per raggiungere grandi città illuminate dal benessere. Impropriamente veniva considerato un genio del “past posting”, in gergo, poussettista, colui che approfitta di quel fermento, tanto amato dai giocatori, per trarne guadagno con trucchi da prestigiatore. Il poussettista cambia il gioco con operazioni di disturbo, punta quando la pallina sulla roulette è già sul numero. Queste azioni, che violano il regolamento, sono dei pretesti per spostare delle fiches, per aggiugerne a gioco fatto senza che il crupier se ne accorga. Ma suo padre era molto di più che un semplice poussettista, si considerava infatti un chirurgo del destino. Era riuscito dopo anni di esercizio a capire quale casella avrebbe raggiunto la pallina nel momento che veniva lanciata sul piatto della roulette. Finalmente aveva capito il motivo di quella vita costantemente sul filo del rasoio, dove ogni decisione veniva presa esattamente nel momento in cui andava presa, né un attimo prima, né subito dopo. Sfrontatezza e rapidissimi calcoli di probabilità erano gli strumenti per appropiarsi di ingenti somme di denaro sotto gli occhi dei direttori di sala indecisi e tentennanti. Era come tirare un elastico al massimo sforzo lasciandolo un attimo prima della sua inevitabile rottura. Suo padre aveva pochi complici che considerava componenti della famiglia con cui divideva il bottino senza avidità. Ma il suo asso nella manica, colei che gli guardava le spalle e che ritirava le vincite era sua moglie, senza di lei non si sentiva sicuro. Una volta gli avevano raccontato che si erano trovati quasi sul punto di essere smascherati, sua madre avendo capito il pericolo si diede alla fuga mentre gli addetti alla sicurezza la rincorrevano per il casinò. Indossava un poncho di cashmire rosso e proprio quando stavano per prenderla se lo levò e lo indossò al rovescio con un altro colore e si mise seduta su uno sgabello davanti al bancone del bar. Gli addetti alla sicurezza le passarono accanto senza notarla e continuarono a cercarla ma lei era già lontana. Scappare era una condizione inevitabile per far si che quell’elastico non si rompesse mai, spesso al momento della riscossione della vincita veniva invitato a non presentarsi più. La fama del chirurgo del destino iniziava a diventare leggendaria negli ambienti del gioco e da questo suo padre era infastidito e sempre più pensieroso, sentiva che il mondo stava diventando troppo piccolo per lui. Iniziò a trasformarsi, baffi e barbe finte, colorazione dei capelli, rughe artificiali e ogni volta che si preparava per uscire sembrava essere diventato un divo del cinema. Ma l’avvento dei nuovi sistemi elettronici, le telecamere, nuove figure professionali in carico nei casinò, esperti fisionomisti, complicarono ulteriormente il lavoro di un genio ormai in declino. Varcata la soglia dei cinquant’anni decise di fermarsi per dedicarsi ai suoi investimenti, ma gli amici, sua moglie e tutti coloro che gli erano vicino sentivano che ormai non era più lo stesso. Era come se all’improvviso, per questioni di salute, fosse stato costretto a seguire una dieta senza sale così da essere privato definitivamente di un piacere della vita. Quando non lo videro tornare dopo tre giorni si preoccuparono e iniziarono a cercarlo. Lo trovarono in una roulotte ai margini di un complesso industriale in compagnia di gente che nessuno aveva mai visto prima, giocavano a poker tra le nuvole di fumo e fiumi di whiskey. Aveva gli occhi fuori dalle orbite, la camicia bagnata di sudore, lo sguardo disperato di chi aveva perso tutto. Continuava a ripetere ormai senza convinzione, come un disco incantato: “Dio fa che stavolta vinca, non ti ho mai chiesto niente, ma almeno questa volta mi riprendo tutti i soldi che ho perso in una volta sola” . Fu caricato in macchina di peso e portato via velocemente mentre i loschi compagni rivendicavano i crediti accumulati. Presto si ammalò, non erano i soliti acciacchi dell’età, il cuore non reggeva più e prima di morire insegnò al figlio tutti i segreti che a nessuno aveva mai svelato. Il figlio sapeva che era un’eredità che non gli sarebbe servita a molto, ma nonostante questo gli sembrò il regalo più bello che avesse mai ricevuto.
Dal carcere
Ci si può innamorare
anche solo delle mani
se il resto del corpo
è dentro a una gabbia
sono mani che amano mani,
come se tutto il resto non fosse importante.
Basta un gesto per dire,
un gesto per fare,
nessuno lo può negare.
Alle otto in punto
Alle otto in punto nella sala relè della stazione di Varenna, il capostazione guardava il suo fischietto, contemporaneamente, una manciata di minuti più tardi Daniele scoccava la sua prima freccia col suo nuovo arco. Sul treno per Milano una bambina dorme in braccio al papà e si è svegliata proprio mentre il viaggiatore seduto accanto aveva finito di leggere un articolo sui titoli tossici. Sul sagrato del Duomo un piccione sfiora la testa di un giapponese, sale in alto e scompare dietro a un palazzo. Lorenza, la panettiera del paese dall’altra sponda del lago a quell’ora era impegnata in un lungo sbadiglio nel suo letto, visto che era Domenica se ne stava rannicchiata sotto le coperte aspettando che scattasse la sveglia. Il diretto per Tirano passa dalla stazione senza fermarsi, corre col suo rumore per scomparire dentro un tubo di roccia. Proprio alle otto in punto una quantità indescrivibile di uccelli che si erano posati sull’unico albero nella via presero il volo, così, tutti insieme, senza una spiegazione. A cinquanta metri dal giapponese ancora un po’ infastidito dall’incidente del piccione c’è un bar con i tavolini fuori. C’è un giovane seduto che si accende una sigaretta con un dispositivo situato all’interno del suo orologio. Si gode quel debole sole che filtra dal cielo lattiginoso mentre all’interno della chiesa un bambino impegnato a cantare starnutisce. Molto più lontano, dall’altra parte del mondo Lucrin si starà fumando una sigaretta al mentolo o starà pensando di fare un altro giro di ballo, mettere i soldi nel cappello e andare a casa.
L'ascensore
Questo nostro strano involucro in transito,
dove si aspetta in silenzio il proprio destino,
dove l'orecchio teso scandaglia
rumori di funi in perenne movimento,
i numeri scorrono veloci di due in due
ci si sente sempre un po' inutili,
e ci guardiamo i piedi.
Corallo
Come quel che par triste
è gioia sulle dita,
mi è sempre parso di veder
corallo come velluto.
Eppure taglia
in un immensità
di lievi ferite
Chi decide la forma degli alberi?
- Gli alberi!-
e quella dei sassi?
- il tempo-
e la luce del tramonto?
- quello è solo un ricordo-
e l'altezza delle montagne?
- quello che ci sta sotto -
e il tempo di un giorno? Chi lo decide?
- Io, ora dormi, buonanotte.-
writing for the theater

Fraternal Compagnia - Laboratorio di teatro civile
LA GUERRA DI FLORA
La scena si svolge in un rifugio alla fine della seconda guerra mondiale, fame, paura, disperazione, sono condivise da un gruppo di personaggi eterogenei
Oreste
un uomo disperato, che non capisce più nemmeno da che parte stare, anarchico e antifascista ma dilaniato dalla sua vicenda personale
Iole
Donna alla buona, senza particolari pretese emancipata ma anche tradizionalista,
Olindo padre di Flora
Un uomo stanco ma soprattutto impaurito e preoccupato
Osvaldo
Qualunquista, vile, fondamentalmente fascista nell’animo
Onofrio
È un personaggio macchiettistico vecchio con voce esile ma ferma, monarchico della prima ora ferito nella prima guerra mondiale
Rachele
In ansia per il bambino di pochi mesi psicologicamente molto provata e impaurita
Flora
Giovane staffetta partigiana
Maria madre di Flora
Risoluta, coraggiosa
___________________________
Oreste
State zitti, Ste tot zett!. Ascoltate, i boati delle bombe si son fatti più lontani. Forse staranno venendo avanti gli Americani, ma poi chi sono questi americani? Che fino a ieri ci buttavano le bombe e oggi ci danno la cioccolata, non mi fido mica di quella gente li. A me hanno portato via tutte le bestie e la casa rasa al suolo, non so nemmeno se dai tedeschi o gli Americani, cosa importa quello che è certo che non ho più niente.
Iole
Ma va là son bravi gli Americani i partigiani ci combattono insieme
Oreste
Da quanto siamo qui?
Iole
Tre giorni, cinque, si fa fatica a tenere in conto senza veder la luce del giorno
Si sente bussare
Olindo
Oh grazie al cielo ci avete aperto, buona sera a tutti, Io sono Olindo
Monti mia moglie Maria e la piccola Flora nostra figlia
Oreste
ne è arrivato un altro che ha il nome con la O, non vi sembra un po’ strano? Ci chiamiamo tutti con la O, io Oreste, quell’altro si chiama Osvaldo c’è anche uno che si chiama Onofrio, e lei entra e mi dice che si chiama Olindo,… risata …roba da pazzi
Iole
ma si dai sarà un caso, ti pare a te che sia una cosa importante adesso? Venite avanti cercatevi una sistemazione siete i benvenuti
Olindo
Grazie, grazie signora. è tutto il giorno che camminiamo e tra l’altro a un certo punto non eravamo sicuri di passare da Gorgoglione e abbiamo fatto bene perché li hanno bombardato tutto.
Siamo scappati dalla nostra casa proprio un attimo prima che arrivassero i tedeschi, abbiamo sentito gli spari ma pensavo che fossero ancora lontani, poi, sentito le voci, abbiamo capito che erano a pochi metri. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di rendercene conto, per fortuna avevamo preso qualche cosa che era rimasta nella dispensa, una coperta…
Flora
non ho mai corso così tanto in vita mia
Maria
...e ancora una volta abbiamo salvato la pelle. Ce la siamo sempre cavata noi, ma se ci prendevano stavolta…tu Flora sei stata bravissima non ti ho mai visto correre così
Flora
Con tutte le volte che ho portato i biglietti mi son fatta le gambe, faccio sempre la strada più lunga, per non farmi prendere da quelle carogne!
Maria
Flora stai zitta!
Osvaldo
lasciamola parlare la bambina che mi interessa, quali biglietti Flora? Quelli che portavi ai traditori del Duce?
Flora
ai partigiani quelli che combattono per la libertà
Osvaldo
la libertà… chi te l’ha insegnata quella parolaccia?
Oreste
Boia d’una miseria bastarda! basta, c’è ancora qualcuno che osa dire la parola duce? Il condottiero dei miei stivali se ne avessi avuti un paio in vita mia.
Flora
mio nonno Ovidio me l’ha insegnata
Oreste
ecco, avete sentito? Ha detto Ovidio, anche lui con la O, ma questa è una maledizione!
Iole
ma che maledizione! Fammi il piacere, beh veramente anche mio padre si chiamava con la O, Oscar, pace all’anima sua
Oreste
ecco vedi, ho ragione io qui stiamo diventando tutti pazzi!
Io so solo che qualcuno pagherà per tutto questo, per tutti quelli che son morti ingiustamente, mica solo a quelli che gli han sparato o che sono finiti sotto le bombe, anche chi è morto per la fame. I miei vicini son morti tutti per i funghi, si erano stufati di mangiare l’erba del fosso. Hanno trovato dei funghi e se li son mangiati, tutti sono morti, uno dopo l’altro con delle sofferenze atroci, e io, cosa potevo fare? Potevo solo vederli morire.
Tutti aspettiamo la nostra morte, chi per colpa o per sbaglio, chi oggi chi domani.
Iole
parla per te, che io ce n’ho ancora da vivere sai, ci tengo a sta pellaccia qui! –
Oreste
ho perso la moglie i figli, come ti giri sei morto, e tutti quelli che son finiti nella fossa per la Libertà, partigiani fascisti, le spie, tutti uguali di fronte alla morte.
Ho salvato la pelle per caso io, siamo qui per caso, e una bomba esploderà esattamente in questo punto, per caso….
Rachele
venga qui a pregare anche lei, pregare fa bene, venga
Oreste
pregate, pregate. Dite a Dio che non ci sono.
Rachele
Non dica bestemmie si calmi, tutti abbiamo le nostre tragedie, tutti siamo qui per sopravvivere le sembra che gli altri facciano tutta la cagnara che fa lei
Osvaldo
come oggi, puoi farci anche dei bei soldi, conosco uno della borsa nera, Omar si chiama, abbiam fatto le scuole insieme, quanti soldi si è fatto, cosa te ne fai di tutti questi soldi gli dicevo e lui mi rispondeva, voglio comprarmi un aeroplano
Oreste
Ma stai zitto che se ci troviamo in questa situazione è per colpa della gente come voi che non ha pietà, che pensa di essere più furba, che se ne frega, perché voi vi vantate di fregarvene vero?
Osvaldo
fallo a chi verrà a salvarci il tuo bel discorsetto sulla libertà, ti ritroverai una pallottola in fronte te lo dico io, qui bisogna saltare sul carro di chi comanda senza pensarci due volte, a me non me ne frega niente di tutto il resto
Onofrio
Onore al Re! Che con ardimento, con tenacia e con sforzo disciplinato ha gettato un ponte sull’abisso di due epoche, miei cari eh, eh eh
Oreste
Lo sapete come lo chiamano il Re? “Sciaboletta“. Perché è basso, gli han fatto la sciabola più corta perché non la trascinasse in terra. Miserabile anche lui….
Onofrio
un uomo di elevata statura strategica
Oreste
una statura così elevata tanto da avere avuto un ruolo decisivo per farci entrare in guerra il 1914
Onofrio
Il nostro Re mio caro, ha avuto altissimi sentimenti verso i suoi sudditi, se lo ricordi
Oreste
Il re ha avallato tutte le leggi liberticide che sono state approvate dal regime fascista se ne rende conto?
Onofrio
come tra se e se - esattamente un metro e cinquantatre centimetri non è affatto vero che è basso
Oreste
ci mancava anche il monarca, si si, adori il suo bel re, faccia pure, ci ha portato lui alla rovina, il suo bel re
Onofrio
Non servono le poesie qui, amico mio… servono i fatti. Non mi serve la libertà, io ho il mio dovere, la mia ubbidienza incondizionata… si. Perché che ne sarebbe di noi altrimenti. L’ho persa anche io la moglie sa? Chi me la ridà la mia Delma, la sua Libertà me la ridà?
Rachele
state a parlare di politica e io non ho più latte! Cosa gli do adesso al mio bambino!
Oreste a tutti
come siamo messi con le provviste?
Iole
e quando mai abbiamo avuto provviste! Sono giorni che non mangiamo
Oreste
eppure l’altra notte giuro di aver sentito qualcuno che rosicchiava di nascosto, ma se lo trovo chi è stato gli faccio mangiare i sassi gli faccio mangiare. Se non mettiamo tutto in comune nessuno si salverà!
Osvaldo
ehi tu, da quando sei diventato il capo qua dentro?
Oreste
fermi, restate dove siete, te lo faccio vedere io il capo. Adesso uno per volta mette quello che ha da mangiare su questo sasso
Tutti
ma non abbiamo niente!
Olindo
Noi abbiamo quello che c’è rimasto non è molto ma lo condividiamo con piacere
Oreste
staremo a vedere. Lei signor monarca svuoti le tasche!
Onofrio
abbassi quella rivoltella per carità!°
Oreste
ah ma bene guarda cosa nascondeva il nonnetto
e quell’altro che si vanta di fregarsene dov’è, vieni avanti verme, levati il cappotto, tu leva le cose che ha in tasca e ritorna al tuo posto.
Tre gallette, una buccia di formaggio, un pezzo di pane. Non è molto ma servirà a riprendervi Prendete signora mangiate, vi sentirete meglio. Il vostro bambino si addormenterà prima o poi.
Rachele
grazie lei è un brav'uomo
Iole
sotterrala la tua pistola se non vuoi finire ammazzato e farci ammazzare a tutti quanti, gli Americani saranno qui a momenti. -
Oreste
è scarica non ho mai sparato in vita mia.
L’avevo trovata nei campi, l’ho presa l’ho portata a casa. Certo non mi faceva piacere dormire con quella roba li accanto, ma nello stesso tempo l’avevo pulita pezzo per pezzo, smontata rimontata pensando che un giorno mi sarebbe venuta utile per difendermi, facendo finta come ho fatto finta con voi.
State zitti, ho sentito delle voci là fuori, ecco stanno arrivando, si si sembrano Americani!

Fraternal Compagnia - Laboratorio di teatro civile
IL VIAGGIO NEL BOSCO
Acqua, quant’acqua che viene giù, è come la nostra miseria, ti entra nelle ossa, non ti dà tregua. Ci sono venuti a prendere, ormai qui non c’è più niente solo lacrime che si confondono nella pioggia, eppure bisogna andare avanti, bisogna sperare che un giorno questo incubo possa finire, che si riprenda a vivere, forse non come prima, ma vivere! Allora penso ai campi di fiori, alla gente che lavora, alla mietitura, all’odore del grano, alle capriole nel fienile e al latte appena munto. E allora i miei passi sono gli stessi di chi ho davanti, le mie orme sono le sue e se arranco nel fango, scivolo nella melma, scavo un appiglio per chi mi sta dietro. Scavo nella terra, si spezzano le unghie, il fango trattiene i miei passi anche le scarpe restano attaccate, restano lì sprofondate nella disperazione, ma bisogna andare avanti, bisogna sperare perché finirà questa pioggia che batte sulla pelle, finiranno i bombardamenti, finirà la paura.
Ci siamo fermati, il bosco sembra ancora più buio, basterebbe un fiammifero per vedere la faccia degli altri, per sapere che sono con loro, che sono stanchi come me e che son pieni di fango, ma guai! Sarebbe solo un fiammifero la rovina di tutti. C’è una donna che deve cambiare il suo bambino e l’uomo grasso ci ha detto che più avanti ci dovrebbe essere un capanno che lui usava per la caccia. Lo cerchiamo in silenzio senza far rumore. Quando vediamo il capanno ci si apre il cuore, aveva ragione il cacciatore, vedo il sorriso della donna che si trasforma in una smorfia, dentro c’è un morto, nessuno ci fa caso, non ci sono tavoli sedie ,solo fango e un odore forte intenso. Il Bambino piange, Mia madre lo prende dalle braccia di sua madre, lo appoggia il bambino sul morto, per non cambiarlo nel fango e lo cambia, la morte e la vita non sono mai state così vicino. Ci raggiungono gli altri, non c’è tempo di raccontare, non in questo momento, riprendiamo il cammino, il bosco si dirada e si sente in lontananza il rumore dei motori dei camion che passano sulla strada. Arriviamo in un punto dove il fango ci fa sprofondare, ci giriamo intorno, uno per volta passiamo come in un guado attenti nel cammino passo dopo passo cercando di sostenerci, di rimanere in equilibrio, sono sicura che il mio cuore batte così forte come quello degl’altri, siamo anime erranti, siamo soli e uniti in questa impresa, penso che se riesco a vivere un giorno potrò raccontare tutto questo, vivere per raccontare, questo è importante, andiamo avanti coraggio!
IL FRATELLO DI FLORA
La scena è composta dal fratello di flora seduto al centro con un telo da barbiere sul corpo, intorno si affaccendano freneticamente donne che lo risistemano, il momento è concitato, c’è poco tempo, le donne entrano e escono di scena portando acqua fumante
Quando hanno aperto le celle, dal fondo del raggio, una dopo l’altra, mentre lo scatto della serratura diventava sempre più forte, tac tac, tac, ho capito era arrivato il giorno in cui finalmente ero libero.
• dammi le forbici-
• un attimo fammi finire
Addio miei amati e odiati muri, addio alle tacche dei giorni incisi con le unghie
• guarda qui come ha ridotto le mani, qui ci vuole del bicarbonato e acqua calda, Flora vai a vedere se trovi dell’acqua calda, guarda che dev’esser molto calda, e se non ce la fai fatti aiutare da Ornella
Flora. Ce la faccio, ce la faccio
Poi la luce, una lama tagliente sugl’occhi, mi sembrava quasi di esser arrivato in paradiso, si perché io me lo merito il paradiso.
• Ma guarda qui è pieno di pidocchi cosa facciamo?
• qui bisogna far bollire i vestiti altrimenti ci impestiamo tutti, vai dalla guardia e fatti dare quel coso…
• cosa?
Ma si quell’affare che spruzza quella roba puzzolente
Il DDT!
• si ecco quello!
Mi son girato e ho visto il volto del mio compagno di cella, un’amicizia attraverso il muri, nell’alfabeto dei battiti, ci siamo abbracciati e siamo scappati via.
Flora. Ecco l’acqua calda
• il vestito a che punto siete, l’avete trovato?
La giacca si, i pantaloni non ancora
E cosa aspettate a trovarli, dai che non c’è tempo,
togliti le brache che le tue vanno benissimo
io?
ma perché proprio le mie?
Fai poche storie…, mammalucco che non sei altro.
• non è giusto però
ho camminato giorni, nei boschi, sulle strade deserte e quando arrivavo in un paese speravo sempre che qualche anima buona mi desse qualcosa da mangiare, e invece? Solo porte sbarrate e occhi dietro le persiane.
Disertore, che strana parola, per alcuni è vergogna, per altri orgoglio, io ho preferito raggiungere i partigiani e unirmi a loro,
ma poi mi hanno preso e hanno congelato la mia vita, giorni mesi anni
a campare come topi a vivere di briciole.
• in un principino lo trasformiamo!
Invece di raccontar le fiabe cambia l’acqua che questa è zozza.
I capelli vanno bene così?
Non li hai fatti un po’ troppo corti?
• va beh ricrescono dai…
va beh un corno! se bisogna far le cose è giusto farle bene, guarda qui la riga dietro è storta e questi ciuffetti?
Quando riuscivo a salire su un camion appena seduto mi addormentavo, tutti andavano a Roma, proprio tutti, un miraggio fra i ruderi e la disgrazia, la speranza in un mondo che è morto.
Ce l’abbiamo del profumo?
- Ma che dici stupida gli uomini non si profumano
A Parigi si
- e poi ti sembra il posto dove si trova del profumo?
A Roma si trova tutto me l’ha detto il mio papà
Into The Aquarius
Teatro Emozionale/ Interattivo
I VIZI CAPITALI
Il vizio si è liberato dalla catena della vergogna, si è intriso in noi. Ha raggiunto il suo scopo, quello di non essere più un vizio. Assolto perché dalla parte dei forti, come i galeotti che scampano alla battaglia e sono finalmente liberi. Poi è diventato il paladino di ricchezza e prosperità, e tutti siamo contenti.
Immaginatevi un mondo senza vizi, immaginatevi vivere solo di poco, certo si fa fatica essere semplici.
Sono superbo solo perchè grazie alla mia statura non sento il fiato dei miserabili che stanno intorno?
Non c’è anima viva che possa comprendere quello che sono, non vale la pena neanche parlarne.
Chissà perché quando si pensa all’avarizia vengono sempre in mente i soldi, fosse solo quello! L’avarizia, quella vera, è tenere per se i propri sentimenti, hai mai visto un avaro piangere?
La lussuria è un vizio obsoleto, abbiamo visto così tanto che siamo diventati cechi, ma se ancora hai voglia di immaginare godrai di non aver scoperto niente.
Guarda quella là sembrava non avesse neanche la bocca per mangiare e guardala adesso, ricca che gli casca l’oro quando passa, è andata persino in televisione, non è giusto però!
Si può avere ancora un primo? - Ma è il quinto! - No perché ho visto che avete anche le lasagne e mi dispiacerebbe non assaggiarle, al limite se non riesco a finirle le lascio.
L’ira non si è mai manifestata in me, è un verme che scava nelle viscere, silenzioso e cieco, strappa la carne con parsimonia e con gli anni ti svuota completamente.
Le solite cose, non so nemmeno cosa non mi va, e perché poi dovrei saperlo? Tanto è sempre tutto uguale, non si capisce nemmeno perché i giorni hanno nomi diversi.
Mi viene l’orticaria quando penso che il mondo gira, gira su se stesso in un giorno solo!
Che spreco di tempo!
Dove s'andrà a finire?
cit. da Woizeck
L'ENCICLOPEDICO
Buonasera,
buona sera, di durata di circa mezz’ora (alle nostre latitudini)
ah non sapevo,
del resto come lei sa l’ha detto anche Dante
“Ci riguardava come suol da sera Guardare uno altro sotto nuova luna”
Insistere
Protrarre a lungo con tenacia o caparbietà un'azione o una linea di condotta
Ma guardi, io veramente pensavo che un orma fosse un impronta
Infatti come lei ben sa l’impronta col piede indipendentemente se sinistro o destro che sia, dell'uomo o della donna che sia o addirittura da una zampa d'un animale feroce lasciata sul terreno.
Imprimere insomma.
certo! Ricalcare…
Ah no mi lasci dire che poc’anzi avete commesso un errore,
chi io?
Recalco si dice
Si
Ricalcare, un orma….
Si mi lasci pensare.
Le proprie orme
Come lei meglio di me saprà l’ha anche scritto Foscolo:
“non ritrovando intorno intorno Ombra di lei, né pur de’ suoi piedi orma
Come per dire…si ricalcò il cappello in testa, per esempio.
dei cani che seguono una pista!
forse lei intende, traccia, impronta, vestigio,
certo un’impronta lasciata sul terreno, soprattutto in quanto costituisca la traccia di un passaggio
la polizia è ormai sulle tracce dei malviventi ….
Un delitto?
Poiché l’ordinamento giuridico non può accordare tutela a interessi socialmente immorali, gli atti di disposizione del corpo (art. 5 c.c.) e in generale tutti i negozi giuridici contrari al buon costume sono nulli (art. 626, 634, 788, 1343, 1354, e1418 mi pare, ma non posso saper tutto
Tornare indietro come giustappunto stavamo dicendo
un segno distintivo
un marchio.
Come naturalmente saprà in passato, veniva impresso sulla pelle
di chi si fosse macchiato di delitti infamanti
un offesa
un atto o comportamento lesivo della dignità, integrità o autorità altrui vorrà dire forse…
si esatto
Come per dire…si ricalcò il cappello in testa per esempio
Che peccato.
un delitto! Sarebbe meglio dire
Si,
Reato di maggiore gravità
E la buon costume?
Un’offesa.
Ma lei sa meglio di me che l’ha detto anche Dante
E se ’l passar più oltre ci è negato, Ritroviam l’orme nostre insieme ratto
Ratto?
Le dimensioni variano dal minuscolo è un topo pigmeo subsahariano di soli 7 grammi negli esemplari adulti, al ratto delle cortecce gigante settentrionale che può raggiungere i 2,6 kg.
Ma se ne intende proprio di tutto lei…
Tutto
una variante, non bene spiegata
già…. mi scusi ma adesso devo andare
ma dov’è finito?
Di spessore o diametro notevolmente ridotto o comunque senza alcun dubbio limitato